Si muovevano, neri e agitati, in balia del vento, tra nubi nere e fluttuanti. Come un aquilone. Erano neri i suoi capelli, come le nubi sopra di noi. Neri anche gli occhi, come l’orizzonte che cercavano, sfuggendo ai miei. La sua chioma si agitava. La faceva armonicamente, come volesse seguire il ritmo del flusso e riflusso dell’onda sulla battigia. La melodia del mare era assordante, furente, un fortissimo di quelli che sullo spartito troviamo solitamente nel rigo finale. Ma qui siamo alla fine o all’inizio? Desideravo tenere saldamente il filo di quell’aquilone. Lo desideravo ora con tutte le mie forze. Ma ogni cosa opponeva resistenza: quegli occhi sfuggenti, il vento che rendeva imprendibili e incontrollabili quei capelli, l’onda fragorosa. Quanto avevo amato quei capelli! Quante volte li avevo accarezzati! Quante volte le mia mani avevano obbedito ai suoi ordini, mentre glieli pettinavo come voleva lei, o meglio, come voleva lei assecondando un desiderio che era tutto mio e affidandomeli con un atto di fiducia che richiedeva rispetto. Ma il vento aveva il sapore del sale in quel momento. Tutto sapeva di sale. I nembi neri oscuravano il sole e, in quel nero che avanzava con naturale semplicità, il nero dei suoi capelli era la cosa più congrua e naturale, più semplice e conveniente, come il nero degli occhi. Semplicità: era la parola che mi veniva in mente, e lo faceva in un momento in cui nulla sarebbe apparso semplice. Non lo era parlare, non lo era sentirsi, non lo era camminare. Ma semplicità poteva significare anche ricerca di un’occasione naturale. E dunque? se lei mi aveva dato appuntamento lì, in spiaggia, in una gelida giornata di fine autunno, nell’unico bar che rimane aperto tutto l’anno, per lei era naturale e semplice che ci vedessimo lì? Naturale e semplice. Dovevo sentirmi ancor più semplice dei suoi piedi nudi che danzavano sulla sabbia bagnata dalla schiuma, più semplice del sorriso che cercava di nascondersi da troppo tempo, senza riuscirci, più semplice degli occhi che sfuggivano alla ricerca di un orizzonte, di un fine indistinguibile. Si era alzata dal tavolino del bar dove eravamo le uniche persone, oltre al titolare che sfogliava un quotidiano. Mi prese per mano. Era naturale anche quel gesto. Mi portò verso la spiaggia, al di là della duna di sabbia, oltre l’esile fascia della pineta costiera. Arrivata alla battigia, si fermò e si sedette per terra. Lasciò che l’onda le bagnasse i piedi. Avevo lasciato la presa della sua mano. Ero rimasto un po’ indietro, per ammirarla. Ero in balia di lei e della sua naturale e disinvolta semplicità; ero in balia di quel paesaggio furioso. Non le volli rubare la scena. Sollevò l’abito lungo nero, quanto bastava perché non si bagnasse e perché il semplice e naturale candore delle sue gambe si illuminasse ancora di più. Mi invitò a sedermi accanto a lei.
La raggiunsi in quella semplice solitudine. Non mi curai di aver lasciato l’auto aperta nel parcheggio del bar e nemmeno di aver lasciato la borsa del lavoro sul tavolino del bar, su cui avevamo appena scambiato quelle parole di convenienza tipiche di quando due persone non si vedono da tempo; neppure di essere in una specie di divisa da lavoro con un completo grigio, mocassini lucidi, cravatta e camicia. Non mi curai, insomma, di essere una forma cittadina del tutto incongruente in quel contesto. Non ero il prescelto protagonista di quella scena. Mi sentivo comparsa. Mi tolsi soltanto scarpe e calze per poter condividere con lei quella fragile posizione di confine tra terra e mare, che lei aveva scelto. Mi tolsi la giacca, allentai il nodo della cravatta e sbottonai il colletto della camicia. E allora mi lasciai coinvolgere dal turbinare a mulinello della sabbia, dall’accatastarsi disordinato delle conchiglie, portate, riprese e riportate dallo sciabordio ritmico della risacca, mentre l’orizzonte univa acqua e aria in un informe magma grigio, agitato dalla bora scura: rinforzava di minuto in minuto e scuoteva tutto, sconvolgeva tutto, mescolava tutto quanto per troppo tempo era stato ordinatamente separato. Iniziavo a capire che non ero una più una comparsa in quel gioco. E quello non era più un gioco.
Avevo ancora trenta minuti di pausa pranzo. Mi parvero un’eternità. Non c’era tempo in quello spazio senza tempo. Non c’era certezza in quel confine, ricco della sua naturale semplicità, un confine che con sicura e beffarda disinvoltura negava ogni certezza.
“Non sai nulla veramente della mia vita.” Pronunciò quella frase appoggiando la testa sulla mia spalla, lei alla mia sinistra, io alla sua destra. Mi dovevo stupire? Con le braccia avvolse le proprie gambe. La imitai assumendo la stessa posizione. L’acqua fredda ci bagnava i piedi. “Credevi di sapere qualcosa, ma non sai nulla.” All’orizzonte le nubi si facevano sempre più nere. Ma lei non se ne curava. Io ancora meno. Il freddo dai piedi cercava di salire dentro di noi. Freddi erano i ricordi. Gelido il passato. Ma intesi la situazione che si creava su quel confine come una necessaria espiazione, in attesa che tutto il caldo conservato dal tempo malato potesse uscire e disinfettarsi. Non parlai. Parlò lei.
“Mi presero in ufficio per la sostituzione di una maternità. Avevano tanto lavoro da sbrigare. Non potevano restare con una persona in meno per così tanto tempo. Forse al direttore piacqui. Chissà. Spero che mi abbia scelta perché brava, ma temo che lo abbia fatto perché gli piacqui.” Era veramente gelido quel ricordo. Sapevo che non era vero quello che aveva appena detto. Il titolare dello studio per cui allora lavoravo anch’io aveva preso informazioni su di lei e sapeva che era brava. Una violenta ventata improvvisamente le scompigliò del tutto la chioma, prima raccolta in uno chignon frettolosamente eseguito, a cui mancava l’amore che un tempo avrei potuto dedicare a quei capelli. La bora li aveva liberati completamente. Li portò sul mio viso. Un’energia e una vitalità che ben conoscevo. Uno schiaffo. Una sberla del vento. Una lezione di quella natura che lì non amava essere contraddetta. Ne afferrai una ciocca e iniziai ad accarezzarli. “Lo facesti quel giorno in cui uscimmo a prendere il caffè dopo la riunione. Lo ricordi?”. Non esitai a rispondere “Sì”. La testa di lei era sempre appoggiata alla mia spalla. Era tutto semplice e naturale.
“Tu pensi che io sia una ragazza dal sud, una di quelle che, come tante, è venuta in cerca di un mondo migliore al nord. Tu pensi che questi occhi neri, questi capelli neri, questo carattere deciso e determinato siano tipici di una donna di origini meridionali. Tanti lo pensano. Donata non è un nome che circoli molto da queste parti. Il mio non è un cognome di queste terre fredde e umide.” Anche questo ricordo era freddo. Stava giocando con il tempo. Avrei risposto dicendo una cosa scontata; avrei risposto dicendo che tante città del nord, soprattutto quelle più industriali come la nostra, hanno una popolazione ormai mescolata, in cui le distinzioni tra nord e sud si sono attutite con il passare delle generazioni; avrei risposto che quella città in cui vivevamo era un grande paese prima della costruzione dell’area industriale, prima dello sviluppo dell’indotto nell’entroterra, avrei potuto anche dire che ormai di quell’immigrazione, che un tempo aveva dato sviluppo e ricchezza, restava solo un ricordo in tanti capannoni che la crisi aveva visto chiudere; avrei potuto ricordarle, sempre per rispondere con freddi ricordi alle sue altrettanto fredde provocazioni, che di quelle tante famiglie, che avrebbero portato la ricchezza proprio con la loro povertà, restano ormai solo nuclei di anziani che vivono di solitudine nei quartieri popolari; avrei potuto dirle che neanche la mia famiglia poteva vantare un pedigree puro, che mio padre era un militare che si era spostato per lavoro in mezza penisola e che mia madre era un’insegnante che cercava di seguirlo dove poteva; avrei potuto annoiarla in tanti modi, rispondendo al freddo con altro freddo, ma risposi con poche parole: “Sapere tutto di una persona può essere impegnativo.” Strozzata dalla bora uscì solo quella risposta. E continuavo ad accarezzarle i lunghi capelli neri che mi avevano fatto sognare, con i miei piedi nudi accanto ai suoi, con la sua testa sempre dolcemente poggiata sulla mia spalla sinistra, con la bora che rinforzava, con le onde che, tagliando di traverso la linea della spiaggia, si accavallavano le une sulle altre. Una risacca cattiva, arrabbiata, che serviva a scuotere il caos del tempo, a rimescolare tutte quelle false certezze che avevano portato solo errori e tanto, troppo dolore. Avevo sempre dato tutta la colpa a me di quegli errori. Il mio ruolo era davvero soltanto quello della comparsa? Avevo letto bene quel copione?
“Ogni tanto ci penso, sai? Penso alle nostre radici.” Disse scandendo le parole. Scuffiai. Non so perché. Mi venne un assalto d’ansia a quel ricordo delle radici. Mi infastidiva. Eppure dovevo assecondarla. Stava per dire qualcosa di importante e, se mi aveva dato appuntamento lì, in quel posto e in quel contesto così particolare, dove solo i suoni della natura dettavano regole, era perché aveva una storia da raccontare. Ormai era evidente. Dimenticare la mia storia e lasciare che protagonista fosse solo la sua. Solo quello dovevo fare. Troppo spesso avevo preteso di imporre le mie scelte. Quell’abisso tutto mio andava trattato con delicatezza. Come il marinaio abbiscia in ampie spire la cima perché poi, si sa, deve essere riutilizzata in modo veloce e agevole, così io feci tesoro delle mie parole. Non parlai.
“Ci lasciammo, o meglio, ti lasciai un giorno di giugno. Eravamo usciti due sere prima. Forse hai dimenticato tutto.” Non avevo dimenticato nulla, ma non parlai, tenendo fede al ruolo di finta comparsa che mi ero imposto. “Andammo a cena in un ristorante di collina. Veramente molto bello. Era sui primi colli. Un posto meraviglioso, di quelli che solo tu sai scegliere. Ricordo come si vedevano chiare e distinte le luci delle città della pianura. Era una serata fresca e limpida. Tanto limpida quanto fu la decisione che presi, ma non ebbi il coraggio di esprimerti.” La sua testa si alzò dalla mia spalla. I suoi capelli sfuggirono alla presa delle mie mani. Il vento li dominava portandoli ovunque intorno a noi due. La bora dava voce alla pineta, poche decine di metri alle nostre spalle: tra quei rami di pino, solitamente placidi, ora agitati e sconvolti, uscivano rumori orribili, fischi acuti; per lei erano voci di divinità dimenticate da secoli che forse chiedevano di essere ridestate. Me lo disse convinta un giorno. Solo la natura aveva di quei poteri, mi disse un altro giorno, uno di quelli in cui la passione invitava a quelle riflessioni. “Finì tutto due giorni dopo. Finì in un’illusione tremenda. Mi illusi di aver chiuso un capitolo, semplicemente come se ne apre un altro, voltando pagina, come quando si fa mentre si legge un libro. Ma non era così che funzionava la vita. Non lo sapevo. Mi illusi che la vita fosse come un romanzo. Ma …” Quella frase incompleta chiedeva forse che io la finissi? Il vento aumentò d’intensità. Un’onda più lunga arrivò oltre i nostri piedi. Il velo nero delle nubi all’orizzonte si aprì per un attimo. Filtrò una luce. Fu come un flash. Poi il vento ricompattò i nembi. La parole che avrei potuto dire ondeggiavano nella mente cercando di uscire, ma, come l’acqua sciaguatta in una bottiglia non ben chiusa durante un viaggio su strada sconnessa, alla fine restarono al sicuro. “Ma …” La vita non è un romanzo. Sì, ne ero convinto anch’io; dovevo darle conferma? Ma era evidente che la vita non è un romanzo. Avrei detto quello che lei stessa avrebbe potuto dire. La vita forse non è un romanzo, ma è l’insieme di tanti romanzi, di tanti stili, di tanti generi; la vita è un po’ noir, un po’ romanzo rosa, un po’ thriller, un po’ anche fantasia e creatività; più o meno delicatamente e pericolosamente condotta su un gioco di psicologie difformi, sempre in bilico, sempre indecisa tra la certezza di un passato, che, bello o brutto, è pur sempre una realtà che ti salta addosso quando meno te l’aspetti, e l’incertezza di un futuro che, quasi sempre, riesce solo a fare tanta, tantissima paura. C’è un tempo per tutto nella vita, per ridere e per piangere. L’importante è sapere che quei due tempi vanno vissuti entrambi, perché l’unico possa essere compreso e vissuto grazie alla consapevolezza dell’altro. Alcuni ne raccolgono tutto il peggio, altri tutto il meglio. E vengono fuori vite più belle e vite più brutte. Fu questo, in tutta la più naturale semplicità, che ci dicemmo quel giorno, quando lei prese la decisione di andarsene. Avrei fatto bene a dirlo? Non lo feci. Le avrei fatto del male? Forse sì. Mi lasciai accarezzare i piedi da quell’acqua gelida che dava l’impressione di una forza più sicura e pulita, più incessante e determinata di quanto fosse il mio animo in quel momento. E, tenendo fede al mio intendimento, non parlai.
“Non sai proprio nulla della mia vita. Ho vissuto una guerra, una vera guerra, una di quelle a cui tuo padre per una vita si è sempre esercitato, ma non ha mai combattuto.”
Pronunciò quelle parole con la voce come strozzata. Lo sciabordare ritmato e regolare del mare vinse e lasciò incompiuta anche quella frase. Sollevai la mano sinistra. Stavo per appoggiarla sul ginocchio destro di lei che continuava a tenersi le gambe strette tra le braccia. Poi la ritrassi. Non appena la mia mano fu di nuovo lontana da lei, la sua mente fu come attratta da un mondo di ricordi e sovrastata da una mole di immagini che sembravano evocare solo dolore. Questo dicevano quegli occhi neri, che io conoscevo molto bene. “Non sai proprio nulla della mia vita.” Era ancora più strozzata quella voce. Mi voltai. I nostri sguardi si incontrarono. I suoi occhi erano lucidi. Di scatto girò la testa verso il mare che lontano mugghiava contro i massi delle barriere frangiflutti. Ascoltai il seguito non più nel ruolo di comparsa presa dalla strada, ma in quello direttamente coinvolto nella trama. Adesso ero un attore vero.
“Sono nata a Mogadiscio. I miei sono del sud. Mio padre era andato a insegnare ingegneria all’università. I rapporti della Somalia con l’Italia erano buoni allora. All’università tutti parlavano italiano. Nessuno di noi voleva sapere cosa ci fosse dietro a quegli accordi. Si lavorava. Si studiava. Dopo la caduta del presidente i miei decisero di restare, quando tutti gli italiani invece lasciarono il paese. Mio padre trovò un lavoro come ingegnere per una società inglese con sede in Kenya. Mia madre perse ovviamente il suo posto. Ci trasferimmo in una zona a sud di Chisimaio, ritenuta dagli inglesi sicura. Una mattina mi svegliai da sola. Erano entrati in casa. Avevano ucciso le tre guardie che ci proteggevano. Dei miei genitori e di mia sorella, più grande di me di due anni, non seppi più nulla. Non so perché mi lasciarono lì. Avevo tredici anni. Fui presa in casa da una famiglia inglese chi mi mise in contratto con la mia ambasciata. Mi trasferirono a Nairobi, in Kenya, dove vennero a prendermi gli zii che vivevano a Milano. Crebbi con i miei cugini, che furono più che fratelli per me. Lo zio venne poi trasferito in questa città, in un ufficio del porto. Per anni siamo vissuti nella speranza che il babbo, la mamma e mia sorella fossero stati rapiti da una banda che ci avrebbe chiesto un riscatto. E invece non si è più saputo nulla. Non hai idea di cosa possa significare convivere con il ricordo dei tuoi genitori e di tua sorella, a cui non puoi nemmeno versare una lacrima in un camposanto. Quella che ho vissuto fu una guerra. Una guerra vera. Una delle più brutte. E per me non è ancora finita.”
Quando si sente il cuore balzare in gola si vorrebbe dire qualcosa, ma non ci si riesce. La mia bocca tentò di aprirsi. Ma le mie parole rimasero dentro. ‘Non dire nulla’: avevo fatto un patto con me stesso. Lei mi prevenne con grande tempismo e accortezza. Ma, anche se avessi parlato, non avrei detto nulla di banale. Pensai solo ai bei momenti passati insieme. Sei anni. Per cinque anni anche colleghi di lavoro. Poi lei si licenziò. Mi lasciò per un altro con cui credo che le cose non siano andate mai bene. Di lei non persi mai traccia. Con una scusa passavo davanti all’uscita del suo nuovo ufficio. Andavo a fare la spesa dove sapevo che andava lei. Quando mi vedeva, non si dimostrava mai irritata per la mia presenza. Al contrario. Mi sorrideva e quei capelli neri, sciolti o raccolti che fossero, quei vivaci occhi neri, mi facevano poi sognare per ore, perché ne ero sempre innamorato, come il primo giorno. Mi convinsi del fatto che il mio errore sia stato quello di non averglielo mai detto abbastanza. Forse nemmeno quando stavamo insieme ero riuscito a farle veramente capire l’intensità del mio amore per lei. Non saprei. Se lei mi ha chiamato qui è per farmi quella rivelazione sul suo passato. E se ha sentito il bisogno di farla, significa forse che esiste un altro bisogno? quello di riaprire un dialogo? Non parlai. Mi aveva appena detto di non dire nulla. Non dissi nulla. Il pensiero andò allora all’altro capo del filo, dove tutto ebbe inizio. E allora tutto mi fu chiaro. Ero sul punto di farla uscire allo scoperto, quando fu lei ad aprir bocca: “Le guerre nascono dall’odio e ne seminano ancora di più nelle generazioni che seguono. Chi le ha vissute da vicino conosce meglio di chiunque altro la forza dell’amore.” Un acuto sibilo di vento interruppe quelle parole. Un tuono molto lontano rafforzò la convinzione che tutto quel passato pieno di putredine e marciume dovesse essere sciacquato via da quella tempesta in atto. Una sferzata di bora le scosse il vestito e le scoprì una gamba. Non se ne curò. Un altro colpo di vento le gettò sul viso la mia cravatta. Sulle mie mani e sulle sue l’aria salmastra deponeva salsedine. Era una sensazione meravigliosa. Un altro tuono. E poi una veloce sequenza di altri lampi e altri tuoni in lontananza, laggiù dove tutto si confondeva, in quell’abisso dove lo spazio era tempo e il tempo spazio.
Era stata assunta da una settimana, ma tutti in ufficio eravamo rimasti colpiti dalla sua bellezza. Succede. Una bellezza speciale, semplice e naturale, come tutto lì era semplice e naturale. Oggi come allora. Era bella. Certo. Aveva tutte le curve al posto giusto. Certo. Avrebbe dimostrato di dare anche nell’amore una soddisfazione che poche sarebbero riuscite a dare. Certo. Tutto era naturale. Di più: per me tutto era semplice. Ma non era quello il sentimento che s’insinuò nella mia vita dalla bellezza che si diffondeva dalla sua. Era altro; era un atteggiarsi della sua persona ora dolce ora vagamente nobile, ora semplice e naturale ora malinconico e misterioso. Fu quello che fece scoccare la freccia. Eppure, non era così misteriosa quella movenza. Aveva dei caratteri definiti. Era un modo di eseguire i lavori ordinati dal suo capo con una naturalezza alla quale erano ignote stanchezza, noia e contrarietà. Era un sentirsi sostanzialmente felice, a proprio agio e serena in quell’ufficio dove rimbrotti e lamentele erano invece assai frequenti. Questa era la sua bellezza, alimentata dalla semplicità: sorridere, sorridere, sorridere. Sorridere facendosi la coda di cavallo. Sorridere leggendo una mail appena arrivata nel computer. Sorridere quando le veniva chiesto di finire un lavoro, che forse avrebbe richiesto un po’ di straordinario. Sorridere quando le veniva chiesto di andare in posta o dal notaio sotto la pioggia. Sorridere al direttore, quando le veniva chiesto come mai era arrivata dieci minuti in ritardo: “Domani arriverò venti minuti prima, se necessario,” rispose un giorno, disarmando in un attimo l’acidità del rimbrotto. Il resto non contava. Un giorno inviammo dai nostri due computer una stampa di un documento alla stessa stampante. Ci trovammo nella situazione più normale che può capitare in un ufficio: davanti al cassetto d’uscita della stampante con due fogli da prendere. Ma non guardammo i fogli. Io guardai gli occhi di lei. Lei guardò i miei. E io presi il documento di lei, lei prese il documento mio. Il fatale sbaglio. L’orario del mattino stava terminando. Appena tornati nei nostri uffici, mi arrivò una mail nella casella personale: “Pausa pranzo al bar sul molo del porto? Ho un documento che forse è tuo e tu forse hai un documento mio. Ce li possiamo scambiare lì, se vuoi.” “Va bene. Andiamo con la mia auto,” le risposi. E fu così che, oltre ai documenti, ci saremmo scambiati i numeri di telefono. E ci lasciammo, senza che io rimanessi fulminato da quei due occhi neri, di cui non avevo conosciuto nulla di più energico e vitale, semplice e naturale. Ricordo solo una cosa di lei. Una sola frase mi rimase impressa: “Ho un futuro che voglio vivere solo nella gioia.” Ora, solamente ora, posso dire di capire quella frase, pensai lì sulla battigia. Ma non parlai.
Ci sarebbe stato bisogno di tante parole. Fu sufficiente una folata di vento. Fu sufficiente che quel vento mi avvolgesse il viso con quei capelli. Fu sufficiente che quel sorriso ritornasse con tutta la sua energia. E allora la mia mano sinistra non ebbe più titubanza. Si protese verso di lei, che non strinse più le ginocchia.
“Credo di avere una cosa da darti ancora. Qualcosa ci deve aver distratto allora.” Estrasse dalla borsa un foglio. Era una fotocopia di un libretto di spese di carburante di un cliente dello studio in cui eravamo stati colleghi. Era il documento di quella stampante di tanti anni prima, quello che avevo stampato io, ma che aveva preso lei. “Forse anche il mio documento è rimasto a me,” le dissi “No, tu me lo hai dato. Io invece mi sono dimenticata. Sono troppo distratta.”
Nubi sempre più nere e mare sempre più infuriato. Il vento sollevava sabbia ovunque. Ci alzammo. Prendemmo le nostre cose e corremmo a sederci al riparo, al tavolino del bar dove avevo lasciato la borsa. Le prime gocce, ancora innocue. Non parlammo di noi, ma di lavoro, di vita di tutti i giorni, di spese, di progetti futuri. Ridemmo tanto. Non c’era bisogno di romanticherie. Il suo modo di parlare, di muoversi, di agire, di comunicare era già tutto plasmato dal sorriso. A me bastava quello. Ammiravo solo quello che per tanto tempo avevo sognato. Conoscevo le radici di quel sorriso. Tornammo insieme in città. Ognuno al suo ufficio. Ma con una promessa. Quella di non essere più distratti. Prima di mettere in moto, presi in mano quella stampa di vecchia fotocopia. E mi sfuggì un sorriso. La piegai con cura e la misi nella borsa.
Ero alla tv quando arrivò un suo messaggio: “Viviamo tutti in bilico, tutti sul confine. Prima eravamo tra acqua e mare, tra sabbia e onde, che si confondevano nel vento di bora. E nemmeno di fronte a noi il grigio del cielo e quello del mare erano distinti. Mi ero illusa che la vita avesse degli scompartimenti, che fosse come un mobile fatto a scaffali, dove i sentimenti, le esperienze, i sogni, gli errori, le emozioni, i ricordi dovessero stare ognuno in un cassetto o in uno scaffale diverso. E invece che non è così.”
“C’è un tempo per tutto,” le risposi. E poi aggiunsi: “E il tempo confonde tutto. Occorre il coraggio di aprire tutti quei cassetti e tutti quegli scaffali. E rimescolare tutto.”
“Va bene. Aiutami.”


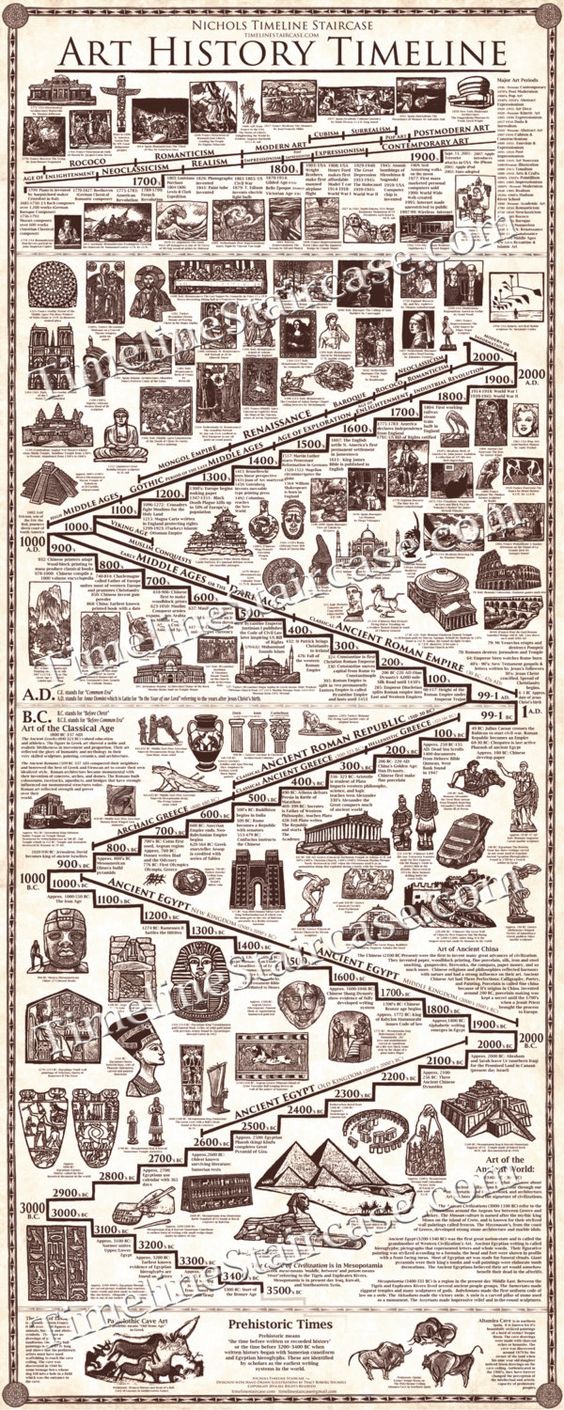




Commenti recenti