Era prevista da giorni. La neve, dopo settimane di clima primaverile fuori stagione, di turisti con il broncio, finalmente era arrivata. Il paesaggio vero, tutto bianco, aveva preso il posto di quello finto con le lingue bianche delle piste disegnate dall’uomo nel verde. La neve era arrivata con il botto, come si dice. Aveva iniziato in tarda mattina portata da vento forte. La nevicata si era poi infittita, sempre di più. Mario, il parrucchiere del paese, e Alberto, suo fratello, proprietario dell’officina meccanica, avevano deciso di chiudere prima del solito le loro attività. Mario era tornato a casa dove ad attenderlo era Sofia, con la naturalezza senza patemi di quelle persone di montagna per cui la neve è la vita e non un problema, come altrove. Alberto, che, viste le previsioni, aveva già applicato lo spazzaneve al suo camioncino, si teneva pronto, insieme ad altri, a rispondere al messaggio del sindaco e a mettersi al lavoro. Ma i due fratelli, sulle porte delle rispettive case, non parlavano della neve. È inutile dire che anche per loro la neve non è un problema, da sempre fa parte del quotidiano tran tran, ma può diventare un problema chi incautamente la sfida. Non di quella, dunque, parlavano. Tema delle loro preoccupazioni era, invece, il loro amico e vicino di casa, insegnante da anni nella loro comunità, da quando aveva fatto la scelta di lavorare in quel paese e in quella scuola; e lì in quella comunità, appunto, da tempo viveva. Il “prof”, come da tutti era semplicemente chiamato, in quanto unico uomo insieme a un bidello a lavorare in quella piccola scuola, destava preoccupazione in tanti quel giorno, da quando Annamaria, che abitava nell’ultima casa prima della rotonda, dove iniziava la strada del passo, aveva comunicato che, prima che questa fosse chiusa, era passata proprio l’auto del prof. Era il gesto che tanti di quelli che gli volevano bene purtroppo temevano e che puntualmente si era verificato. Non era la prima volta che lo faceva da quel giorno di gennaio di dieci anni prima, quando, sempre sotto una fitta nevicata e sempre con la strada del passo chiusa, il prof era andato nella sua baita, in realtà una piccola casetta con piano terra in pietra e alzato in legno, che il marito di Annamaria, geometra, aveva trasformato in un rustico e caldo ambiente, un locale unico, una grande monolocale, una specie di loft. Gli volevano tutti bene, perché era un bravo insegnante, era persona sensibile, era amato dai suoi ragazzi, stava spesso con tutti loro al bar, nella piazza, nel giardino pubblico, faceva sport con loro, partecipava con loro all’organizzazione di tutti gli eventi per i turisti, così come a quella degli aiuti nelle situazioni di bisogno, nelle calamità naturali. Ma gli volevano bene soprattutto dopo quello che era successo anni fa quel giorno di gennaio.
Alberto ricorda meglio di tutti quanto successe allora, in quella giornata che lasciò un segno, un brutto segno, in tutta la comunità. La strada del passo era stata chiusa e non ancora pulita dopo un’abbondante nevicata. Arrivò alla stazione dei carabinieri una chiamata di soccorso da parte di una donna rimasta bloccata: evidentemente era uscita da una delle strade private e non era a conoscenza della temporanea chiusura di quella principale. Fu Alberto a salire con lo spazzaneve e a trovare la Cinquecento bianca ferma in mezzo alla bufera, bloccata nella neve. Lei era visibilmente alterata. Alberto, che la conosceva bene, non l’aveva mai vista così: la donna nervosamente si asciugava il viso con un fazzoletto e cercava in modo innaturale e maldestro di dissimulare un malessere che trapelava in modo palese. Alberto riuscì ad estrarre l’auto dalla neve e a metterla dietro il suo mezzo. Disse alla donna di seguirlo standogli vicino. Provò a fare domande sul prof, ma non ebbe alcuna risposta. Arrivati alla fine della discesa, in fondo alla strada, alla rotonda dove iniziano le case del paese, Alberto intravvide una mano che ringraziava da dietro un finestrino appannato. Da quel giorno la Cinquecento bianca e chi l’aveva guidata, popolando fantasie di ogni tipo nelle menti della gente del paese, non si vide più. Dieci anni erano passati. E la piccola comunità sentiva la mancanza di quella Cinquecento bianca. La avvertiva immancabilmente quando vedeva lui, il loro prof, e quando realizzava il cambiamento che quel giorno aveva apportato all’esistenza sua e alla vita di tutti loro. Quando Alberto tornò al bar, vide Mario che gli disse che il prof non rispondeva al telefono. Sapevano tutti che era lassù. Cosa fosse successo non si seppe mai. Lui non ne parlò mai a voce. Erano per tutti loro in paese una coppia bellissima e affiatata. Lei era un’insegnante di educazione fisica di una scuola di città, che portava spesso i ragazzi a sciare e a fare escursioni con le ciaspole, altrove note come racchette da neve, nelle piste del loro paese. Il barista del rifugio, Halit, un gioviale quarantenne di origine balcanica, gli aveva parlato di un’insegnante di una scuola di città, “una donna affascinante”, che veniva spesso con i ragazzi sulle piste del passo: nel suo linguaggio semplice e con il suo lessico decisamente diretto e ben poco allusivo non mancò più volte di dire nei suoi messaggi quale notevole esemplare del genere femminile fosse quel giorno arrivato al rifugio. Un giorno in un messaggio Halit descrisse la giovane insegnante in tutti i particolari fisici, partendo ovviamente dalle parti più curvilinee, che a lui evidentemente interessavano di più, e concludendo con la descrizione dei particolari che invece solleticarono l’interesse del prof: “ha un naso molto particolare, aquilino, lineamenti del viso marcati, un alone vagamente orientaleggiante che noi balcanici, mescolatici per secoli con i turchi, sappiamo riconoscere subito, un piccolo neo vicino al naso, occhi neri vivacissimi, una chioma di capelli neri lunghi che è una meraviglia della natura e un sorriso che spakka”. Nessuno seppe se tutto fosse dipeso dalle quelle due kappa o dal neo, o dai capelli, o dalle curve descritte centimetro per centimetro da Halit, fatto sta che il prof decise di associarsi un giorno con i suoi ragazzi a quelle uscite, che lo incuriosirono, e organizzò un’escursione con le ciaspole con una sua classe, non appena ebbe da Halit la data della prossima comparizione della ‘misteriosa divinità orientale’. Fu così che un bel giorno al rifugio su al passo, proprio sui tavoli dove Halit serviva la pasta e fagioli, a detta di tanti la più buona di tutta la valle, i due gruppi, quello del prof e quello della divinità orientale, si fermarono per il pranzo e si incontrarono. La freccia di Cupido evidentemente fece centro, quando i due insegnanti si conobbero e Halit, ammiccando con il prof, disse: “Sono fiero che nel mio rifugio sia appena nato un gemellaggio tra due scuole. La quota degli accompagnatori è offerta dalla casa.” In effetti, trattandosi di un giovedì, giornata infrasettimanale, quei due gruppi di quasi sessanta persone, compresi gli altri due colleghi del prof e dell’insegnante della scuola di città, avevano portato in cassa una cifra che per Halit era assolutamente insperata. Alberto era arrivato al passo, passando per il sentiero nel bosco, che incrociava il pianoro della sua baita; l’altro gruppo aveva preso un’altra mulattiera estiva, che per anni era stata usata come tracciato per una pista di sci di fondo nei mesi invernali. A tavola il prof convinse la collega appena conosciuta a passare per il bosco, dicendole che il panorama sarebbe stato molto più bello, ma che bisognava prestare attenzione ad alcuni tratti ripidi. Halit vide subito dai sorrisi che si scambiavano, dal modo in cui parlavano, da come il prof avesse quasi dimenticato di avere la responsabilità di un gruppo di ragazzi, che la famosa alchimia chimica era scattata. “C’è qualcosa di incredibilmente misterioso che unisce queste due persone”, scrisse nel massaggio che inviò ad Alberto e Mario, che sapeva in paese non solo vicini di casa, ma anche amici del prof. In pochi minuti tutto il paese seppe. Alberto non vide subito il messaggio, ma Mario sì, lo vide subito e rispose: “Ma lui è così timido …” Halit ribatté: “Anche lei. È questo il bello.” Al ritorno verso il paese, da cui erano partiti per quella escursione con le ciaspole con il gruppo dei ragazzi, passarono infatti proprio dalla carrareccia, che dal passo giungeva alla sua baita e diventava poi lo stradello privato, che portava alla strada principale. Il prof e lei rimasero sempre insieme in fondo al gruppo. Lui, che conosceva benissimo quella pista, spesso aiutò lei nei punti più ripidi. Da lì scendeva anche un sentiero, da cui si arrivava in paese più velocemente a piedi, quello che il prof con i suoi ragazzi avevano già percorso in salita. Alberto li incontrò su quel sentiero e vide che in un tratto un po’ più ripido e delicato il prof era particolarmente attento ad aiutare i ragazzi ad affrontarlo nel giusto modo. Vide anche che per ultima passò lei. Ma la donna scivolò, perdendo l’equilibrio e finendo proprio in braccio al prof. Alberto ebbe la conferma dei sospetti di Halit, nel momento in cui assistette al bacio che i due si diedero quando lei si rialzò, ridendo spensierata e per nulla preoccupata della brutta figura fatta con i suoi ragazzi. Da quel giorno lei veniva su al paese sempre più spesso con la sua Cinquecento bianca. E non si presentava mai alla casa di lui in paese: alla rotonda girava sempre per la strada del passo e poi prendeva la sterrata che andava alla baita. E quella Cinquecento bianca era diventata in certo senso parte delle fantasticherie che tutti in paese iniziarono a raccontare, costruire, inventare, modificare, rielaborare con dettagli sempre nuovi sul loro prof. Era una piccola epica di paese quella che si ambientava in quella baita e che stava prendendo forma nelle riunioni a tavola delle famiglie al termine del dure giornate di lavoro, che la stagione turistica imponeva per il divertimento altrui. Era bello quando la mattina presto scendevano insieme dalla baita, abbracciati per fare colazione insieme al bar, prima che lei scendesse in città alla sua scuola e lui andasse a sua volta alla sua scuola, la loro scuola, la scuola del loro paese, dove tutti loro avevano passato un po’ della loro vita. Era bello il modo semplice in cui il prof e la ‘misteriosa divinità orientale’ dichiaravano a tutti di essere innamorati.
Il loro prof da anni scriveva. Aveva iniziato con delle poesie di ambientazione montanara, ispirate ai sentimenti che da quel paesaggio scaturivano nella sua immaginazione. A loro piacevano, ma il genere della poesia, apprezzato dai lettori locali, raccoglieva scarso interesse giù in città. Decise allora di passare alla narrativa ed ebbe più successo. Sempre racconti di montagna e sempre lei, in forme diverse li popolava, con la sua chioma di capelli neri, i suoi occhi neri, il suo accento orientale. Nessuno di loro aveva mai saputo da dove venisse quello splendore del genere femminile che, ogni volta che faceva la sua apparizione nel bar del paese, lasciava a bocca aperta tutti, soprattutto gli uomini, con quel suo fisico atletico, sempre tonico e perfetto, quei capelli che ora lasciava ondeggiare con voluttuosa civetteria, ora raccoglieva in una lunga coda di cavallo, che spesso era lui a farle lì al bar, accarezzandoglieli morbidamente, incurante degli sguardi altrui. Il piccolo birichino neo a fianco del naso leggermente adunco, la spia che per tutti loto tradiva l’inconfondibile origine orientale, ma dantesca per lui e la sua immaginazione mai convenzionale, era stato oggetto di tante ipotesi sulla sua origine. Benché si fosse conquistata l’epiteto di ‘misteriosa divinità orientale’, parlava tuttavia italiano perfetto. Non solo: rispondeva alle battute in dialetto, quello di città un po’ imbastardito, ma apprezzato ugualmente dai più puntigliosi puristi locali. E quegli occhi vivaci? Avevano un potere unico di sprigionare fiamme di passione in chi ne fosse colpito. Quanto era bella! Una bellezza di quelle che lasciavano il segno non tanto perché espressa da un fisico, quanto perché diffusa da uno spirito che, potente in modo ineffabile, emanava ogni sua forza al suo passaggio; una bellezza che passava per il sorriso, per gli occhi, per quella leggera e morbida chioma di capelli neri, che sembravano parlare muovendosi in modo così delicato e sinuoso. Aveva avuto proprio un bel fiuto il prof, dicevano spesso, nelle più svariate coloriture che il loro dialetto consentiva. Lo invidiavano. Sì, non riuscivano a celare, anche espressamente nei suoi confronti, la loro bonaria invidia per quella meraviglia di collega di educazione fisica che aveva trovato e che, seppur discretamente, faceva ormai parte della loro comunità. Ma Alberto e Mario avevano sempre nutrito grande rispetto per lui e per la sua storia con lei; all’inizio qualche battuta piccante sulla bocca di qualcuno c’era stata. Poi i due fratelli erano prontamente intervenuti a difesa del prof e nessuno aveva più osato esprimere né pensare mai niente di volgare né di offensivo. Era un atto di amore di un paese intero quello che accompagnava e partecipava a quella presenza nella baita, due chilometri fuori dalla strada del passo. Una passione che animava, che infondeva vita, ma che, soprattutto, ispirava rispetto per qualcosa che loro non avevano mai capito da cosa derivasse. Era il loro prof, gli volevano bene, lo avevano accolto, scriveva di loro cose belle, lo faceva con naturalezza e semplicità. Era uno di loro, senza se e senza ma. Che fosse quella la ragione che ispirava quel senso di autorevole semplicità che era nell’aria intorno a lui? Che fosse quello il suo alone particolare? Era un carisma anche quello, in un modo o nell’altro, un carisma fatto di gesti semplici, alieno da protagonismo, ma ricchissimo di affetto e solidarietà.
Alberto e Mario erano quelli che più di tutti s’intrattenevano con lui. Abitavano nelle case del paese da cui partiva il sentiero che, tagliando per il bosco, arrivava direttamente alla baita. Lo vedevano più frequentemente, perché, molto spesso scendeva e risaliva a piedi da lì, quando, anziché a casa in paese, andava su alla baita. Anche d’inverno. Quante volte dentro la loro testa gli avevano dato del matto, vedendolo infilare le pedule nelle ciaspole e salire su per l’erta, nella neve non battuta se non da lui, con lo zaino pesante di libri! E quando passava di lì lo salutavano felici, perché sapevano che lassù andava ad aspettare lei.
Da quel giorno di gennaio il prof era cambiato. Non scriveva più quando si trovava nella sua casa in paese, ma soltanto quando andava su alla casetta, dove trascorreva, spesso da solo interi fine settimana. D’estate o nelle vacanze di Natale riceveva qualche visita da parte dei suoi due fratelli, sempre giù in paese, mai su alla casetta. Non si muoveva più dal paese. Quando uscì la prima raccolta di racconti, fu intitolata Il tempio della memoria: tutti in paese capirono che il riferimento era alla baita. E da allora tutti capirono che là dentro covava qualcosa di meno bello, di molto diverso da quello che per tanti anni la loro epica di paese aveva immaginato e costruito. Il prof non riusciva più a sorridere come prima. Il dolore lo stava rodendo. Quando andava lassù produceva pagine diverse da quelle di prima, pagine più forti, più vissute, più passionali, riuscendo a esprimere sentimenti che neppure loro, nati lì, sarebbero riusciti a cogliere in quel modo. Trasferiva nel paesaggio quella passione che aveva perduto nell’anima; riempiva con il paesaggio il vuoto che lei aveva lasciato lassù, nel ‘tempio della memoria’. Quei testi scritti dopo quella giornata di gennaio, rimasta indimenticabile negli annali della piccola comunità, erano più belli, ma lui no. Lui, dentro di sé, nella sua anima, non era più bello come prima per loro. Lo capivano al momento della colazione al bar. Lo capivano nel bar della scuola all’intervallo. Lo capivano quando si fermava in chiacchiere a commentare il giornale da Mario. Lo capivano sulle panchine del giardino pubblico. Lo capivano quando con Alberto trascorreva ore davanti a un grappino che durava eternamente, tanto a lungo quanto interminabili erano gli sforzi dell’amico per capire cosa stesse succedendo alla sua anima. Alberto, da sempre appassionato di letteratura di montagna, leggeva con passione i suoi racconti e aveva capito di quei testi qualcosa che altri forse non avevano percepito. Il prof se ne era accorto. Lo ascoltava con piacere, ma in silenzio, senza mai dargli la soddisfazione di aver compreso un riferimento particolare, di aver interpretato una metafora rappresentata da un animale, da una figura del paesaggio, da una scena. Mai. Ascoltava in silenzio. Annuiva con il capo. Prendeva in mano il bicchierino di grappa. Lo annusava più volte senza bere. Quando beveva, lo faceva a sorsi lentissimi. Ogni incontro terminava con la stessa frase: “Grazie, Alberto. Sei un amico.” Frase che rafforzava un’amicizia, ma che ad Alberto sembrava non servire a risolvere un problema. E ne soffriva quando lavorava nella sua officina, pensando all’amico, vedendolo passare a piedi, per inerpicarsi per quel sentiero che conduceva alla baita: un viaggio dell’anima ormai per lui, la dolorosa erta al ‘tempio della memoria’. Allora Alberto avvertiva una speciale ma discreta attrazione verso l’amico: usciva dall’officina, lo seguiva finché riusciva a vederne la sagoma salire su per il bosco. E dentro di sé la sua anima di uomo di montagna, da sempre abituato ad essere sì devoto e religioso, ma soprattutto solidale al momento del bisogno, comprendeva lo stato di chi in quel momento non era felice; e non mancava di rivolgere nel suo animo una preghiera che accompagnava quella faticosa e dolorosa salita alla baita, ben diversa da quella di anni prima.
Qualcuno si era informato giù in città. Sembrava che lei si fosse trasferita. Voci raccolte qua e là dalla curiosità della piccola comunità parlavano di un genitore di uno studente, titolare di un importante studio commerciale in una città vicina dove lei si sarebbe trasferita, convinta da lui ad abbandonare le tristi e malinconiche montagne per la più viva città. Queste voci si rincorrevano di casa in casa e arrivarono anche a lui ovviamente, tanto piccola era la comunità. Quella che non era più la ‘misteriosa divinità orientale’ sarebbe più volte stata vista in locali notturni insieme a questo benestante professionista, che con vera classe le apriva gli sportelli della sua auto sportiva, la riempiva di gioielli e abiti eleganti, la portava nei locali più esclusivi. Così almeno si diceva. E lui, vere o false che fossero le voci, soffriva. Quanto doveva soffrire! Per la piccola comunità era una grande persona il loro prof. E quelle notizie facevano male non solo a lui, ma anche a tutta la piccola comunità, che lo amava con affetto sincero da sempre, da quando lui aveva scelto di vivere da loro. La sofferenza era dunque generale. Era una specie di epidemia. Alberto e Mario raccoglievano quelle voci su di lei, cercavano di sottoporle al più attento setaccio e poi le mettevano a confronto con quanto avveniva in quella baita, al termine di una stretta strada privata, che s’inerpicava ripida su un pendio, che terminava in un piccolo pianoro. Ricordavano quando lei veniva su con i ragazzi della scuola e ricordavano che su al rifugio del passo i due stavano sempre insieme a tavola a mangiare. Ma le donne del paese avevano altri modi per pensare a loro: ricordavano soprattutto che erano stati la coppia dei sogni per molte di loro. Il giornalaio ad alcune signore affezionate ai romanzi rosa faceva spesso la battuta: “Ma che bisogno ne avete? Non l’abbiamo qui in paese il più bello di tutti i romanzi rosa? Perché comprate questa roba scadente?” Era un romanzo rosa. Sì. Il loro prof era diventato anche quello: il protagonista di un romanzo rosa. Ma a lui non dispiaceva, tutto sommato, recitare quella parte, che si era trovato cucita addosso da quell’antica e resistente tradizione popolare fatta di semplicità, ma soprattutto di sentimenti che giudicava genuini. Alla fine dei conti, se era lì a lavorare, era perché la amava, quella comunità, anche per quegli aspetti che lui definiva, solo con chi capiva il significato non offensivo del termine, atavici e primordiali. Non c’era niente di male. Erano per lui brave persone. Gli volevano bene anche così, facendo di lui una specie di JR. Lui ne voleva tanto a loro, in compenso. E non mancava di farlo capire, appena gli si presentava l’occasione. Si aiutavano a vicenda tutti. E aiutarsi tutti a vicenda significava anche regalare un sorriso alle tante persone con le quali il suo lavoro lo metteva in contatto quasi quotidianamente: al genitore che veniva a un colloquio, appena reduce da un lutto familiare; alla mamma del ragazzino disabile che aveva in classe per farle capire che lui comprendeva che il dolore non era solo del ragazzino, ma anche di chi con lui doveva passare giornate intere; allo studente in una di quelle crisi adolescenziali d’amore che anche lui aveva vissuto e passato. Era questo che piaceva di lui a quella piccola comunità che lo aveva saputo accogliere. Non parlava. Appariva poco. Ma quando lo faceva, in un modo o nell’altro lasciava un segno e lasciava sempre un modo per far parlare di sé. Dava a loro l’impressione di non pensare mai male di nessuno. I manuali di psicologia sociale sentenziano e pontificano, dichiarando che non è facile interagire con quei gruppi chiusi, soprattutto nelle valli di montagna; lui ci era riuscito. Perciò: o era lui l’eccezione che confermava la regola, o erano i manuali dei corsi di psicologia sociale da rivedere. Insomma, che importava se la baita, il suo tempio della memoria, era diventata per loro lo spazio narrativo di un romanzo rosa? Stava così bene insieme a loro che accettare questa parte, sicuramente non entusiasmante per i più, per lui era invece il modo per ricambiare l’affetto che loro manifestavano per lui. E a lui piaceva così. Lontano dai riflettori, dedicando ore a pensare e a riflettere sui tanti errori che nella giornata poteva aver commesso.
Era religioso, dicevano di lui i paesani. Andava a messa ogni domenica. Ma non si sapeva mai di che genere fosse veramente il suo essere religioso. Ai ragazzi in classe non parlava bene delle religioni nel loro complesso, soprattutto di quelle che avevano nel tempo assunto un carattere più istituzionale. Non mancava di mettere in luce i difetti del monoteismo. Per lui la divinità doveva necessariamente assumere le forme che la situazione richiedeva, non poteva avere una struttura monolitica, non poteva essere incarcerata in dogmi. Ne parlava sempre. Eppure andava in chiesa e pregava. Pregava tanto. I suoi racconti erano pervasi fortemente di questo afflato spirituale, in cui entravano riflessioni che erano quelle delle sue lezioni ai ragazzi più grandi del corso scientifico. Questi tornavano a casa, ne discutevano in famiglia, i genitori spesso non capivano i contenuti dei testi di cui i ragazzi parlavano, ma una cosa la capivano, e molto bene: la fede di quell’uomo era forte e incrollabile. Tutto stava nel capire in che cosa egli avesse fede, se nei monumenti della natura di cui tutti erano circondati, se nei fenomeni atmosferici come il vento o la pioggia, se nel ciclo eterno con cui tutti questi si ripetevano, se nel tempo, di cui spesso parlava a scuola, affrontando con profondità l’analisi di testi di Seneca e Agostino. Nessuno lo aveva mai capito. Eppure quante volte lo vedevano fermarsi un attimo davanti alla chiesa, salutare con un caloroso abbraccio il parroco ed entrare in canonica; e poi vedevano accendersi la luce dello studio del parroco: quella luce rimaneva accesa per ore. Chi abitava vicino alla chiesa parlava di due persone che discutevano animatamente, che prendevano libri e leggevano e spesso il tono di voce era alto, come se litigassero. Il parroco veniva da lontano. Era nato in una famiglia polacca non cattolica. Durante l’occupazione tedesca, un suo nonno, ebreo non osservante, si era convertito al cattolicesimo, facendosi cambiare a pagamento addirittura il cognome, per paura delle rappresaglie; durante il comunismo sua mamma denunciava al partito chi andava in chiesa. Quell’uomo ne aveva tante davvero di esperienze da raccontare e lui ascoltava, ma certe cose sembrava che non le capisse. E spesso in chiesa, durante l’omelia, vedevano il prof con i gomiti poggiati sulle ginocchia, mentre scuoteva la testa tra le mani. Ma perché discutevano così animatamente e così a lungo là dentro, nello studio del parroco? Il giornalaio, che, come accade spesso nei paesi di montagna, vendeva anche libri, diceva che il parroco conosceva parola per parola i suoi racconti, ma, quando veniva a prendere il giornale e lui gli chiedeva se gli erano piaciuti, non aveva mai osato dire di sì. Eppure si capiva lontano un miglio che al parroco piacevano. Eccome …
Gli ultimi racconti che aveva scritto parlavano per immagini. Erano più difficili. E per molti di loro i riferimenti più profondi, ora anche di tipo filosofico, diventavano ardui da comprendere. Ma una cosa li colpiva: il titolo dell’ultima raccolta era L’ultima curva. Perché li colpiva questo dettaglio? Tutti conoscevano quella strada che arrivava lassù alla casetta e tutti sapevano quanto fosse pericolosa per chi andava su in salita quell’ultima curva, al termine di un tratto impegnativo e molto ripido anche per un’auto, molto stretta, a gomito, quasi un tornante che girava attorno a uno sperone di roccia appuntito, che sembrava voler tagliare la strada. Appariva spesso, in quei testi molto diversi dai primi, pervasi da un sentimento di dolore abilmente dissimulato, una figura femminile che scompariva dietro quella curva. E questa figura era quasi un’ossessione. Il prof dipingeva anche nel tempo libero. E le ultime opere, che a loro piacquero tanto che finirono in quasi tutti i negozi del paese, attiravano l’attenzione dei turisti che vedevano spesso quella figura femminile di spalle con una lunga chioma di capelli neri, sempre raffigurata su una strada in procinto di curvare a destra. Era una strada di montagna, era una strada costiera a picco sul mare, era una carraia di campagna, era un vicolo di periferia urbana: ma la curva e la figura femminile di spalle non mancavano mai in quelle rappresentazioni. Era diventata proprio un’ossessione. Ma con il prof nessuno aveva il coraggio di parlarne, di indagare, di chiedere o soddisfare una semplice curiosità. Sia chi sapeva di più, sia chi sapeva di meno, tutti quanti gli volevano troppo bene per profferire parole che gli potessero fare troppo male.
Alberto partì con lo spazzaneve. Mario tornò a chiudere il negozio. Molte case si prepararono ad affrontare quella serata di neve, tanto attesa da tutti. I messaggi tra di loro avevano compiuto ormai il loro giro: non erano pochi quelli che pensavano a lui. L’auto del prof, ultima a essere passata dalla rotonda e ad aver imboccato la strada del passo, prima che fosse chiusa, li preoccupava davvero. Era quello soltanto l’ultimo di uno dei tanti comportamenti che negli ultimi dieci anni lo avevano reso oggetto di preoccupazione per tanti di loro. La neve scendeva veramente fitta. Non c’erano più auto in circolazione, se non quelle degli ultimi che rincasavano dal lavoro. I pochi turisti erano tutti nei locali al caldo. Tutti si erano raccolti nelle case al sopraggiungere delle prime ombre serali. Tranne lui.
Arrivò con l’auto all’inizio del bosco sotto una bufera di neve, la cui intensità andava crescendo di minuto in minuto. Le gomme termiche non bastavano. Dovette montare anche le catene, quando ebbe lasciato la strada principale – la via maestra, la chiamava lui – per quella privata, che portava alla sua baita, al tempio della memoria. Sollevò la sbarra e accese il lampioncino, che segnava l’inizio della sua strada privata. Da dieci anni non lo accendeva. Funzionava ancora. Ripartì lentamente nella bufera: la neve si stava alzando di livello sul manto stradale. Erano quelli per lui i due chilometri più belli e più sofferti allo stesso tempo, ogni volta che saliva lassù. Ogni azione sul volante era un ricordo di lei. Ogni movimento dell’auto lo portava istintivamente a cercare lei al suo fianco, sul sedile vuoto del passeggero. Persino i fasci di luce dei fanali, che gli sbalzi violenti dell’auto sul fondo innevato agitavano qua e là, su e giù, sembravano quasi cercare lei tra le folate di neve. Le curve della strada, la dolcezza di quel posarsi della neve fiocco su fiocco, il vento che sembrava avere un carattere diverso a ogni curva e che a ogni curva sembrava modellare il paesaggio stesso in modo diverso, tutto rimandava a lei, tutto rimandava a quelle meravigliose escursioni con le ciaspole con i ragazzi delle loro scuole e a quelle che loro due per tanti anni in quel bosco, che conoscevano come le loro tasche, avevano fatto insieme. Ogni curva era un sorriso di lei, che lì un giorno era stato donato a lui. Ogni curva era un abbraccio, che lì un giorno era stato goduto insieme. Ogni curva era un bacio, che lì un giorno era stato assaporato con passione. Ogni curva era una frustata al cuore. E ogni curva che veniva superata era un supplizio, che diventava sempre più insopportabile nell’attesa della più terribile e devastante di tutte quelle curve, per la sua anima fatta a brandelli da dieci anni di salite e discese solitarie per quella strada verso il tempio della memoria. E quel concetto di curva non era per lui solo banale richiamo alla bellezza di lei, ma soprattutto era il correlato del tormento per tutte le difficoltà e le tortuosità, che avevano avuto come conseguenza l’abbandono di quel luogo da parte di lei. E l’immagine tornava lassù, al pianoro finale, alla baita e a quello sperone di roccia che costringeva la strada a piegare in una curva stretta e pericolosa. E infine all’immagine che era la madre di tutti i dolori da anni: il momento in cui, della sua meravigliosa figura che aveva già passato la curva, il vento riportò alla sua vista per un attimo la lunga chioma di capelli neri. Ossessioni, ammalianti e crudeli ossessioni, che il tempo aveva reso ormai signore incontrastate di quel meraviglioso e affascinante paesaggio dell’anima, di cui era schiavo. La strada passava attraverso il bosco. La neve, che turbinava e contro la quale il tergicristallo sembrava ingaggiare un’impari lotta, non riusciva a modificare i ricordi. Il suo scendere copiosa rendeva sempre più difficile il procedere. La strada saliva ripida e, salendo, aumentava l’intensità della nevicata. Ma l’erta più dura, quella in cui le forze del motore non sarebbero bastate, era quella che avrebbe condotto all’ultima curva, dopo la quale avrebbe visto la baita: mordace e ormai solo canzonatorio premio del doloroso salire, da quando lei non c’era più lì accanto a lui, su quel sedile vuoto. Occorrevano anche le forze dell’anima per affrontare quell’erta finale e soprattutto quella curva. Occorrevano forze superiori, per riuscire a passare oltre, senza avvertire la solita angosciante tortura, che quella curva rappresentava per lui da quel giorno di gennaio di dieci anni prima. Quella curva aveva dato vita a immagini che erano diventate incubi e ossessioni. Aveva deciso di sfruttare quelle ossessioni scrivendo. E aveva pensato che intitolare l’ultimo libro L’ultima curva, ricordando proprio quel tratto di strada, che tanto significato aveva assunto per lui, potesse essere un modo per esorcizzarlo una volta tanto. Forse qualcosa era successo. Non sapeva se fosse andato a segno o no l’esorcismo, ma un segnale era arrivato. Il più inatteso di tutti i segnali: un messaggio di lei.
Lo aveva ricevuto in giornata, quando la neve era ancora una chimera nei bollettini meteo per tanti di loro. E quel messaggio lo aveva portato lassù, incurante delle proibitive condizioni atmosferiche. In quel messaggio lei, che si era fatta sentire nuovamente dopo anni di silenzio, gli diceva che aveva letto il suo ultimo libro, L’ultima curva. “Mi piacerebbe parlarne con te. Magari lassù forse certe cose si potranno chiarire meglio. Non so se mi crederai o no. Conoscendoti forse non mi crederai. Ma questi racconti mi hanno commossa. Oggi verrò su. Costi quel che costi. Sono già in viaggio.” Laconica fu la sua risposta: “Ti aspetterò lassù”. “Ti manderò un altro messaggio quando sarò vicina”, concluse lei.
Anni di silenzio. Anni di tormento. Anni di sofferenza con gli occhi fissi su quella maledetta ossessione, che popolava incubi e generava immagini, di cui ormai era schiavo. Quella curva. Immetteva in uno spazio aprico baciato dal sole e libero da alberi, dopo aver attraversato un bosco opaco, per chi saliva. Introduceva in un mondo oscuro di angosce e tormenti, per chi scendeva. A chi saliva dava il premio della luce. A chi scendeva rammentava il dolore della tenebra. Era questa solo una delle immagini che nelle sue ossessioni essa aveva assunto.
Trovò uno spiazzo in cui il vento aveva accumulato meno neve e fermò l’auto. Scese. Non era molto freddo. Non aveva guanti, né berretta. Tirò su il cappuccio dell’orsetto che indossava. Il vento forte lo muoveva e non riusciva a tenerlo fermo sulla testa. Ormai era lontano dalla strada principale. I rumori delle poche auto, che in quella tormenta avevano osato muoversi, non si sentivano più. Non sapeva che dopo il passaggio della sua auto la strada per il passo era stata chiusa. Prese il telefono. C’era campo. Lo sapeva che in quel punto si prendeva bene. Anche per quello si era fermato. Conosceva centimetro per centimetro quel bosco. Attendeva un altro messaggio. Non era arrivato. L’ansia in cuore montò. Ne approfittò per chiamare Alberto; l’amico in quelle giornate solitamente guidava il mezzo che puliva la strada principale. Sapeva che per una buona grappa avrebbe volentieri fatto un giretto anche sui due chilometri della sua strada. Alberto stava infatti lavorando e gli assicurò che, appena finito il giro su fino al passo, nel tornare in paese avrebbe fatto la deviazione fino alla sua baita, ringraziando della grappa. Ora aveva un impegno da rispettare. Prima di ripartire controllò i messaggi. Niente di nuovo. Ripartì. Lo attendeva il tratto più impegnativo, gli ultimi 500m. La bufera non cessava d’intensità. Ma era abituato ad affrontare quelle condizioni. L’auto saliva lentamente e faticosamente. Quella lentezza e quella fatica non erano solo nel procedere dell’auto, nell’arrancare del motore e nello slittare delle ruote: erano la sofferenza accumulata in anni di solitudine decretati dalla perdita dell’unica persona con cui la sua vita avesse conosciuto una parvenza di felicità al di fuori del lavoro e delle conoscenze della vita del paese. Non fu semplice, con la pendenza dell’ultimo tratto e l’intensità sempre maggiore della nevicata, arrivare a quell’ultima curva. L’ansia cresceva maledettamente, come sempre. Quando la vide da lontano, come sempre, il cuore balzò in gola. Come sempre avrebbe voluto evitarla o percorrerla a occhi chiusi. La temeva. Ne aveva terrore. Ne aveva rispetto. Ma allo stesso tempo ne era anche fortemente attratto. Era la curva dell’ansia, del dolore, della separazione. Era la curva che segnava il momento in cui la sua vita aveva preso quella direzione, che non si era mai rassegnato a stimare definitiva. Non vedeva la strada, non vedeva la neve, il vento non portava più fiocchi contro il parabrezza: il vento portava una morbida e fluente chioma di lunghi capelli neri su quel parabrezza. Il vento giocava una partita che aveva il sapore della sfida con la sua anima. Il telefono suonò. Si fermò di nuovo. Era Mario. “Non ti sei fermato. Ho visto la tua auto passare dalla vetrina del negozio. Non avrai intenzione di andare lassù proprio oggi? Non andarci: è pericoloso. Fermati qui per questa notte. Domani andiamo a pulire la strada e potrai entrare in casa tua. Sofia ha fatto una torta di mele e passare due ore a chiacchierare con te ci fa sempre piacere.” Troppo tardi. Era già a poche centinaia di metri. “Grazie, Mario. Sono quasi arrivato. Sarà per un’altra volta.” Arrivò subito il nuovo messaggio: “Testone che non sei altro. Un giorno o l’altro veniamo lassù e te la buttiamo giù quella baita. Ti sta rovinando. È la tua rovina.” Non rispose. Arrivò alla curva. Avrebbe voluto chiudere gli occhi, ma sapeva che se avesse mai chiuso, anche solo per un attimo, quelli del volto, si sarebbero immancabilmente illuminati quelli dell’anima. E avrebbero fatto male. Un’attrazione malvagia, crudele, una forma di tortura lo teneva inchiodato a quella curva stretta. La frangia rocciosa, in quel punto imponente, di cui la strada seguiva la forma, curvando in modo repentino, non consentiva di vedere niente del tracciato da qualunque parte si guardasse in quella direzione. Ma era l’altra direzione, la direzione in discesa dalla casa alla strada principale, quella che recava più dolore. L’ansia era alle stelle. Ancora quella chioma di capelli: il vento, come in un gesto di crudele tortura ordito per lui, li riportò indietro, mentre lei aveva girato la curva e lui urlava il suo nome in preda alla disperazione dalla soglia della baita. Erano gli incubi di anni di richiami a distanza. Erano gli incubi che avevano preso forma nei racconti dell’ultimo libro. Lei li aveva letti. Lui non lo avrebbe mai immaginato. Andò avanti con la forza d’inerzia. L’anima rispondeva con la forza del dolore alla forza del motore, che faceva salire l’auto. Quella curva era stata più volte fotografata, tante volte dipinta; quella curva era oggetto di ossessione nei suoi sogni; quella curva era sempre popolata di figure fantastiche, che assumevano di volta in volta forme diverse, ora rassicuranti, ora inquietanti. Quale figura questa volta sarebbe apparsa nella sua mente? Si aspettava le figure dei suoi sogni e invece fu sufficiente l’apparizione fugace di un solo corvo nero, sulla neve bianchissima, per far salire ulteriormente l’ansia. Passò la curva. E con il cuore in gola, gli occhi bagnati e l’ansia alle stelle, arrivò finalmente allo spiazzo in cui era stata ristrutturata la vecchia baita abbandonata. Una casetta in legno immersa nella neve gli apparve alla vista. La sua casetta con la base in pietra e tutto l’alzato in legno. Il tempio della memoria. Lì dove i momenti più belli della sua vita prendevano forma attraverso lo scavo della memoria. Ma tra i tanti momenti belli ogni tanto se ne intrufolava anche qualcuno di quelli meno graditi nella memoria. Ed era sempre quella curva appena passata, quell’ultima curva della strada, a collegarsi a queste intermittenze negative. Il tempio della memoria richiedeva dolorosi sacrifici.
Quante notti come quella erano state trascorse lassù senza quell’ansia, senza quell’angoscia, senza che quella casa e quella strada con quella curva stramaledetta iniziassero a caricarsi di tutti quei significati! La neve impediva l’accesso. La pala era nella casetta degli attrezzi. Dovette raggiungerla, ma era esterna, distante dalla baita; ci riuscì solo affondando fino al polpaccio nella neve fresca, caduta a quell’altitudine assai più copiosa che giù in paese. Aprire la porta non fu facile. Neve recente e ghiaccio meno recente l’avevano bloccata proprio bene. Alla fine ci riuscì, entrò e prese la pala da neve, con la quale pulì il viottolo d’ingresso. Compiva quei gesti quasi in preda a una frenesia che guidava irrazionalmente i suoi muscoli. Quando ripose la pala, alzò l’interruttore generale della corrente elettrica. Si accesero i lampioncini bassi esterni che delimitavano l’area di proprietà: lo spiazzo del pianoro e la parte della strada coperta dalla neve fino alla curva. Disinserì l’antifurto, che aveva dovuto contro voglia far installare per via della posizione isolata della casetta. Dovette spalare molto, prima di poter liberare la porta d’ingresso. La neve aveva lavorato bene accumulandosi proprio tutta lì. Ma quella fresca, ancora soffice, si spalava ancora bene. Lavorò con pazienza, mentre il vento gli faceva ancora volare su e giù il cappuccio dell’orsetto. Aveva sempre amato quel lavoro, quel movimento della pala che dava forma a un viottolo, un viottolo che portava alla strada, una strada che arrivava a quella curva; e lì l’amore prendeva altra forma: la forma della dolorosa separazione di due strade in una via. Chi resta di qua, nel terreno noto e rassicurante della pace della casetta di legno e pietra in montagna, chi va oltre, affidandosi a un ignoto che ha assunto la forma dell’infida libertà. Ma per altri potevano essere diversi i significati. Molto diversi. Ora odiava quella curva, ora ne era attratto in modo affascinante, come spesso capita con gli oggetti che diventano ossessioni della mente e di cui si resta schiavi. Come di un pericoloso feticcio.
Spalando arrivò prima allo spiazzo dove aveva lasciato l’auto, poi alla strada. Non ebbe il coraggio di alzare lo sguardo, che lo avrebbe portato a quello sperone di roccia, che costringeva a quella brusca deviazione. Tornò indietro senza ormai più la possibilità di trattenere il cappuccio, che il vento faceva svolazzare e la neve aveva ormai completamente bagnato. Entrò in casa, lasciando gli scarponi e l’orsetto tutto bagnato sull’ingresso. Andò subito ad accendere il camino. Si sedette in attesa. Il geometra aveva lavorato bene, per realizzare quella specie di ambiente unico: il piano terra era un’ampia sala con cucina e un bagno; da qui una scaletta in legno a chiocciola portava su un grande soppalco con una camera e un secondo bagno. Il camino riscaldava tranquillamente tutto, ma c’era anche l’impianto di riscaldamento a gasolio. Tanti tappeti riscaldavano ulteriormente un bellissimo pavimento originale costituito da un parquet che il geometra aveva voluto conservare, come i rivestimenti in legno delle pareti. Un divano, due poltrone, un tavolino di cristallo, un tavolo angolare in legno con panca a elle e l’angolo cucina completavano quell’ambiente, che lui aveva saputo conservare con gusto. Non essendo quindi grande come abitazione, il camino la riscaldò in tempo, per offrire un ambiente abbastanza accogliente. Andò di sopra e si gettò sul letto a occhi chiusi lasciandosi vincere dal dolore e dalla memoria a cui quel tempio era stato consacrato. Proprio nel momento in cui accese il cellulare e rilesse la chat con lei, fu infatti scosso dal clacson del camion spazzaneve: i suoi pensieri, o forse i suoi sogni – chissà se si era addormentato? – erano popolati come da anni dalla stessa figura e dalla stessa curva. Era solo quella stramaledetta curva che lo attirava lì a quella casetta, a quel tempio della memoria. Questa volta un messaggio.
Alberto scese dal camion, si scosse la neve dalla giacca, lasciò gli scarponi all’ingresso ed entrò dicendo, “Ma cosa c’è in questa tua testa per venire quassù in giornate come queste? Mario è preoccupatissimo. Mi ha telefonato per raccomandarmi di venire a controllare che tutto andasse bene. Siamo preoccupati in tanti per te.”
“Siediti, Alberto. Grazie per essere venuto a pulire la strada. Sarai stanco. Da quante ore stai lavorando?”
“No. Non sono stanco. Sto male per te.”
“Lo vuoi un goccio?”
“Non potrei, ma lo prendo volentieri.”
Andò al mobiletto bar ed estrasse della grappa ghiacciata, di cui riempì un bicchiere, che Alberto non si fece pregare di bere.
“Se continua a nevicare così, dovrò ripassare fra qualche ora. Non lo dirò a nessuno. Lo faccio per te.”
La strada era privata e la pulizia sarebbe spettata al prof, non ai mezzi pubblici. Ma siccome lui in paese aveva aiutato tante persone, soprattutto anziane, ed era molto amato da tanti, nessuno aveva mai protestato se con il mezzo pubblico qualcuno saliva a pulirgli la strada; di quanti lavori e lavoretti fatti dalla gente del paese nella sua casetta sarebbe stato in debito? Alberto si sedette per bere con calma la sua grappa. Lui restò in piedi con la faccia rivolta al muro, davanti a un quadro. Alberto sapeva bene chi aveva dipinto quel quadro e sapeva bene che tutto in quella casa era in un modo o nell’altro legato alla memoria, al passato, alle emozioni, ma soprattutto, purtroppo, alle ormai malinconiche ossessioni di un tempo e di una vita che da tanti anni si era come ibernata, anche per la loro piccola comunità. Lo vide poi spostarsi dal muro alla finestra e guardare fuori. La finestra dava sul davanti proprio in direzione della strada e dell’ultima curva, prima di arrivare allo spiazzo della casetta.
“Ora dovrei andare. Se hai bisogno, chiama”, gli disse, alzandosi, dopo aver lasciato il bicchiere sul tavolino. Gli si avvicinò. Gli pose una mano sulla spalla. La lasciò a lungo lì sopra la spalla di lui. Poi con tutte e due le mani in silenzio gli prese la destra. La strinse. Uscì in silenzio. Il suo camion fu seguito dal suo sguardo, finché non scomparve dietro quella curva. Alberto conosceva i racconti. Sapeva che l’ossessione di lui era legata al fatto che l’aveva vista andarsene, seguendola con lo sguardo e cercando disperatamente di trattenerla con gli occhi, visto che le braccia non c’erano riuscite, fino a quando non scomparve dietro quello sperone che costringeva la strada a una brusca piega. Alberto ricordava quanto spesso quella chioma di capelli che il vento respinse indietro all’improvviso avesse assunto nella sua mente la forma di un beffardo segnale del destino. Per lui invece adesso non era più beffardo quel segnale.
Con il calare della luce, diminuì anche l’intensità della nevicata. I fiocchi ora danzavano più leggeri, portati da un vento meno furioso. Riprese il cellulare in attesa del messaggio. Niente. Lo richiuse. Mentre mangiava un toast, per placare l’ansia in attesa della cena, il telefono suonò. Era ancora Mario che gli chiedeva se avesse bisogno di qualcosa. Gli disse che aveva tutto e che non gli mancava niente. In paese la notizia che il prof era andato alla casetta sotto il passo era ormai di dominio comune. Come di dominio comune era che nessuno avrebbe mai potuto impedirgli di andarci, quando lui sentiva il bisogno di salirci. Nemmeno una bufera di neve di rara intensità come quella. Uscì fuori e sulla neve fresca con il manico della pala, quella usata per tracciare il viottolo che portava all’ingresso, scrisse una frase.
Sofia disse che forse era il caso di andarlo a trovare, se Alberto aveva pulito la strada. Mario le disse che lui, se andava là, era perché non voleva altri con sé, che aveva da anni la sua casa in paese e che, se la lasciava per la baita, c’era una ragione che non stava a loro indagare. Sofia era preoccupata che gli potesse succedere qualcosa. Mario no. Sofia insisteva perché almeno si informasse se tutto andava bene, perché le previsioni meteo non erano buone. Mario le rispose che anche lui lassù poteva informarsi sulle previsioni meteo. Alberto però aveva avuto un particolare presentimento, quando, scendendo, dopo essere stato dal prof, arrivato all’incrocio con la strada principale, dove c’era la sbarra, aveva visto accesa la luce che indicava l’inizio della strada. Era stata sempre spenta quella luce da anni. Perché quel giorno il prof l’aveva accesa? Alberto non si fece domande. Sapeva che qualcosa di diverso dal solito stava accadendo. Si augurava in cuor suo che fosse qualcosa di bello, perché nessuno aveva mai avuto ragione per volere del male a quell’anima che da tempo visibilmente soffriva. La neve continuava ad accumularsi anche sulla strada principale. Riprese il suo lavoro di pulizia su e giù dal passo al paese. Arrivato al passo, al bar del rifugio gli fu offerto da bere di nuovo da Halit. Secondo strappo alla regola. Arrivò l’auto dei carabinieri. Uno dei due diede una pacca sulla spalla ad Alberto dicendogli che anche Luciano, il proprietario del secondo mezzo spazzaneve in paese, si era messo in moto su loro richiesta, data l’intensità della nevicata, e che in due avrebbero lavorato meglio, ora che l’intensità stava diminuendo. Fu una buona notizia. La solidarietà di paese era una pacca sulla spalla che il carabiniere gli diede. Valeva più di tanti grazie. Si parlava di chi abitava nelle case private e degli stradelli privati di accesso. I carabinieri avevano i cellulari di tutti quelli che abitavano in quelle case, tranne quella del prof, perché era una seconda casa: lui abitava giù in paese e, come dissero tra di loro, confermati dal proprietario del rifugio, da Halit, in una giornata come quella non gli sarebbe sicuramente saltato in testa di andare lassù. Alberto tacque. Tacque anche alla battuta del proprietario del rifugio che disse che dopo la nota vicenda il professore era diventato imprevedibile. “Allora andiamo a fare un salto?”, chiese l’altro carabiniere. “Per quella strada? Ma sei matto?”
“Il prof è in paese”, mentì Alberto, ammiccando ad Halit.
“Uno in meno. Problema risolto”, disse il primo carabiniere. Sapevano che gli uomini del paese avevano una chat per le emergenze, in cui comunicavano tra di loro e in cui avevano inserito anche i cellulari dei carabinieri della stazione. In questa chat particolare attenzione veniva sempre rivolta alle persone anziane e a chi abitava nelle case più isolate.
Alberto salutò tutti e riprese il suo lavoro. Uscendo, come sempre i suoi occhi si posarono sulla piccola vetrina con i libri in vendita, tra i quali in bell’evidenza era proprio quello dell’ultima raccolta di racconti di montagna del loro amato prof intitolato L’ultima curva. Mentre metteva in moto il camion, arrivò un messaggio sul cellulare. Era Mario. “Non ci crederai. Sofia ha detto di aver visto una Cinquecento bianca girare alla rotonda su per la strada del passo.”
Alberto mise in moto e scese fino al bivio con lo stradello della baita del prof. Aprì la sbarra. Pulì la strada fino all’ultima curva, senza farsi vedere da lui e spegnendo i fanali nell’ultimo tratto. Tornò indietro. Richiuse la sbarra e scese in paese. Mentre scendeva, vide salire la Cinquecento bianca, che tutti loro conoscevano bene e che da tempo non vedevano più. Rallentò. Fu riconosciuto. Salutò con un lampeggio. Lei rispose con un altro lampeggio, procedendo lentamente in salita. Per Alberto era come se quei dieci anni non fossero mai passati. Era contento di aver pulito la strada adesso. Mandò messaggi a mezzo paese dalla gioia. Alberto viveva da vedovo da ormai sette anni e come pochi comprendeva il significato di una perdita; e proprio in quel momento si rendeva conto più che mai della differenza che c’era tra quelle irrimediabili e quelle invece rimediabili. Era veramente contento di aver pulito la strada. Fu l’ultimo a vederla quel giorno di dieci anni prima in circostanze atmosferiche quasi identiche. Allora aveva pulito la strada per renderle più facile la partenza. E si sentiva in parte responsabile per quel gesto. Ma adesso avvertiva come la liberazione di un peso dall’anima. La strada era pulita e la Cinquecento bianca poteva arrivare senza problemi alla baita.
Sofia, che, dopo aver letto i racconti de L’ultima curva, si era dedicata alla lettura del precedente romanzo del loro prof, disse a Mario, che stava entrando nel letto dove lei era già stesa a leggere: “Penso che questa neve non sia un male che viene per nuocere questa sera.”
“Da noi la neve non è mai un male che nuoce, Sofia. Com’è quel libro?”
“Particolare. Come lui che l’ha scritto, del resto. Sono tutti racconti di storie che finiscono qualche volta male, qualche volta bene: e alla fine c’è sempre un bivio, una curva, una scelta sbagliata. Qualche volta si rimedia all’errore, altre no. Sono tutti ambientati qui e sembra quasi che lui li abbia scritti … come dire … non trovo le parole, Mario.”
“Forse volevi dire che sembra che li abbia scritti con la sguardo fisso su quella strada, su quello sperone di roccia e su quella curva stretta?”
“Ecco, sì. Forse sì. Forse hai ragione. Ma come fai a capirlo se non li hai letti?”
“Non lo so. Mi è venuta un’idea, così …”, mentì Mario, che in negozio aveva invece letto il libro nelle pause tra un cliente e l’altro. Non seppe dire esattamente perché avesse mentito. Troppi significati aveva quella curva anche per lui. Troppe complicità lo legavano a quell’amico particolare. Cosa che del resto capitava anche a suo fratello Alberto. Quante ore in negozio a parlare di quella giornata in cui lui, il loro prof, cercò disperatamente di aggrapparsi alla vita e all’amore, che tanto faticosamente aveva costruito e tanto generosamente legato a quella casetta! Quante ore a parlare di quella giornata in cui i colori belli e luminosi della tavolozza si erano come spenti, seguendo la figura di lei passare dietro quella curva e svanire nel nulla! Quante ore a sentirsi descrivere quella chioma di capelli che il vento rimandò indietro improvvisamente, malignamente e beffardamente! Anche suo fratello Alberto pensava, nel suo andare su e giù con lo spazzaneve, a quell’auto che aveva incontrato. Quante sere su al rifugio di Halit il prof gli aveva parlato di quella casa e di quella strada, di quel bosco e di quella curva! Ogni racconto partiva sempre da lì, da quella curva, e lì finiva. Alberto sapeva che quel libro che aveva letto era più importante di quanto avesse creduto. L’aveva preso per fare piacere al prof. Non era un grande lettore. Eppure gli aveva spalancato un mondo immenso, seppur contenuto nell’anima di un solo uomo.
Il forno era caldo, pronto per cucinare l’arrosto con le patate, il piatto che per tanti anni era stato quello dell’accoglienza di lei su alla baita. Il tavolo fu apparecchiato per due. Accese nell’attesa la tv della casetta, in cui il segnale arrivava appena, ma sufficiente per sintonizzarsi su un canale radio che trasmetteva buona musica. Il camino crepitava bene e tirava a meraviglia. Aveva ormai riscaldato perfettamente la casa. Lui era seduto con il telecomando in mano, quando arrivò il messaggio. La suoneria era quella. “Sto arrivando.” La Cinquecento bianca arrivò alla casetta nello spiazzo illuminato dal lampione, la cui luce arrivava fino alla curva. Una sagoma femminile nella penombra scese dall’auto. Indossava una tuta da sci e un paio di pedule. Come d’incanto la bufera si era placata. Lui la seguì mentre si avvicinava alla porta. Non aveva niente in testa. I luoghi capelli neri erano sciolti. E fu quello che spalancò l’anima e la liberò da ogni dubbio. Un tempo scioglieva sempre i capelli quando si voleva concedere a lui. Sempre. Era un segnale che per anni lui aveva ritenuto appartenente a un codice esclusivo tra loro due. Lui glieli avrebbe poi legati in una coda di cavallo, con gesto lento e delicato, quasi accarezzandoglieli. Non sapeva che in dieci anni lei non si era mai più legata i capelli in una coda di cavallo.
La figura femminile, quella che fu la ‘misteriosa divinità orientale’, si portò lentamente verso la baita, con il volto rivolto in basso, sulla traccia di sentiero che lui aveva spalato sulla neve. Prima di mettere i piedi sull’assito del pavimento del loggiato d’ingresso, trovò una frase disegnata sulla neve fresca: “Questa è sempre stata casa tua. Non avere più dubbi!”
Lui era sulla porta. Lei si era avvicinata ai tre gradini di accesso. Salì sul primo. Si voltò indietro. Vide la curva nell’oscurità, oltre la luce del pianoro illuminato. Quando lei arrivò vicino a lui, rimase con il volto basso. Non osò alzarlo. Lui non si mosse. Fu quella morbida e fluente chioma nera, che fu portata a lui da una folata di vento, ad accarezzargli il volto. Lei allora alzò lentamente il viso. Il suo era già in attesa. Lei si alzò sui piedi e portò le braccia sulle sue spalle. Lui sorrise. Non la abbracciò subito, come se esigesse altri segni e dimostrazioni. Lei aveva viaggiato tra mille dubbi. “Non avere più dubbi!”, le aveva scritto lui nella neve. Una lacrima solcò il volto di lei. Lui gliela asciugò.
“Questa lacrima è l’ammissione di un errore durato dieci anni?” La sua voce uscì strozzata. Il suo sguardo tornò alla curva, dietro le spalle di lei. “Eppure per me tu sei sempre stata lì, dietro quella curva.”
Lei non rispose. Si voltò verso la curva di cui aveva letto tanto in quegli anni, rimanendo con le braccia sulle sue spalle. Fu allora che lui la abbracciò e la tenne a lungo stretta a sé. Tutti e due avevano lo sguardo adesso nella stessa direzione, concentrato sullo stesso luogo, laggiù, oltre lo spiazzo illuminato. Ognuno dei due si faceva la stessa domanda che nessuno di loro aveva il coraggio di fare all’altro: “Quanto male ti ha fatto in questi anni?” Abbassò le mani dalle spalle di lui e da una tasca della giacca estrasse il libro. Entrarono. La porta si chiuse alle loro spalle e in un attimo il freddo della bufera e il buio delle sera furono sostituiti dal caldo del camino e dalla luce di due anime che per tanti anni si erano cercate e ora si erano ritrovate nelle pagine di un libro.
Lei, con il suo libro in mano si pose accanto al camino; glielo pose di fronte agli occhi tenendo il viso basso. Non riusciva a far entrare i suoi occhi in quelli di lui. “Non avere più dubbi!” Dubbi forse non ne aveva, ma vergogna e rimorso non erano ancora usciti dal cuore. Gli occhi di lui adesso erano bagnati. Gli occhi di lei anche. Una comunicazione durata dieci anni era in quelle pagine. Lui tentò di incontrare gli occhi di lei. Lei non riusciva ancora ad alzare i suoi. Il libro cadde per terra. Si abbracciarono di nuovo in silenzio. Lei scoppiò in un pianto dirotto. Liberatorio. Lui la lasciò piangere. Poi andò all’ingresso e abbassò l’interruttore delle luci esterne. Non più un fiocco di neve scendeva. Non un soffio di vento spostava più le fronde. Tutto si era fermato per assistere all’atto finale di una commedia, che sembrava avesse preso in giro un paese intero per dieci lunghi anni. “Era nell’ordine naturale delle cose che succedesse”, disse lei, trovata finalmente la forza per alzare gli occhi e incontrare quelli di lui. Salì su per la scala a chiocciola, diretta alla camera. Lui la seguì. Lei si spogliò: la morbida chioma nera le scese sulle spalle, mentre, come era stata sempre loro tradizione, metteva foglie d’acero ai piedi del letto.
L’ultima curva non era più illuminata e non era più diversa dalle altre. Mario dalla finestra della sua casa in paese vedeva la strada che conduceva alla baita e aveva visto spegnersi le luci. “Credo che sia arrivata su da lui. Forse per noi tutti ricomincia qualcosa di nuovo. Chissà …” Alberto parcheggiò il camion e guardò in alto, in direzione del bosco, che seguì fino in cima, fin dove finiva la strada della baita. Le luci esterne, l’unica cosa che di sera si vedeva dal paese, non erano più accese. Nulla era più diverso. Tutto era tornato come doveva. Come era giusto che fosse. Era giusto anche che quel lampioncino all’inizio dello stradello fosse acceso. Era giusto che la strada fosse pulita. Era giusto che la loro Cinquecento bianca fosse tornata. Spense le luci del camion. Scese nella neve. Entrò in casa. Gli occhi si posarono su un quadro di lui, il suo ultimo regalo, addirittura del giorno prima: una donna di spalle in ombra su un pontile, rivolta verso un lago, una lunga chioma di capelli neri, una luce sfuocata su di lei, in lontananza un pendio illuminato da un violento raggio di sole, un bosco, una strada, una casetta. Lo guardò bene. Guardò attentamente il particolare della strada e della casetta: mancava qualcosa in quel quadro, che gli era stato appena regalato. Mancava la curva. Sentì il cuore balzargli in gola e gli mandò un messaggio: “Bravo prof! Siamo tutti con te!” Halit dal rifugio scrisse un messaggio a tutti nel gruppo delle emergenze: “Al passo non nevica più. Sapete niente del prof?” Alberto gli rispose per primo: “L’ho sentito poco fa. Sta bene, Halit. Finalmente credo che stia bene.”
La strada che portava al tempio della memoria, anche in quel particolare suo tratto finale, ripido e tortuoso, aveva ripreso i colori di tutto il resto del paesaggio, finalmente addormentatosi e placatosi. Era stato duramente provato dalla furia degli elementi per tante ore. Ore di ansia per tutto il paese. Tutti loro ebbero pace. La bufera era finita. Loro erano tutti sereni. Le luci delle case del paese si spensero una ad una. I turisti l’indomani avrebbero trovato tanta neve fresca sulle piste. La baita fumava di nuovo al buio, emanando un calore che da dieci anni nessuno aveva più sentito.
E anche lei, l’ultima curva di quella strada che conduceva al tempio della memoria, l’indecifrabile, enigmatico simbolo di uno di quei metabolismi della vita di cui nessuno dovrebbe mai osare interpretazioni dettate da una qualsiasi logica, era rientrata, come del resto era inevitabile, nell’ordine naturale delle cose.

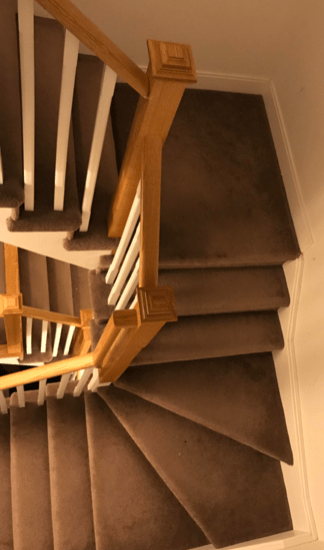









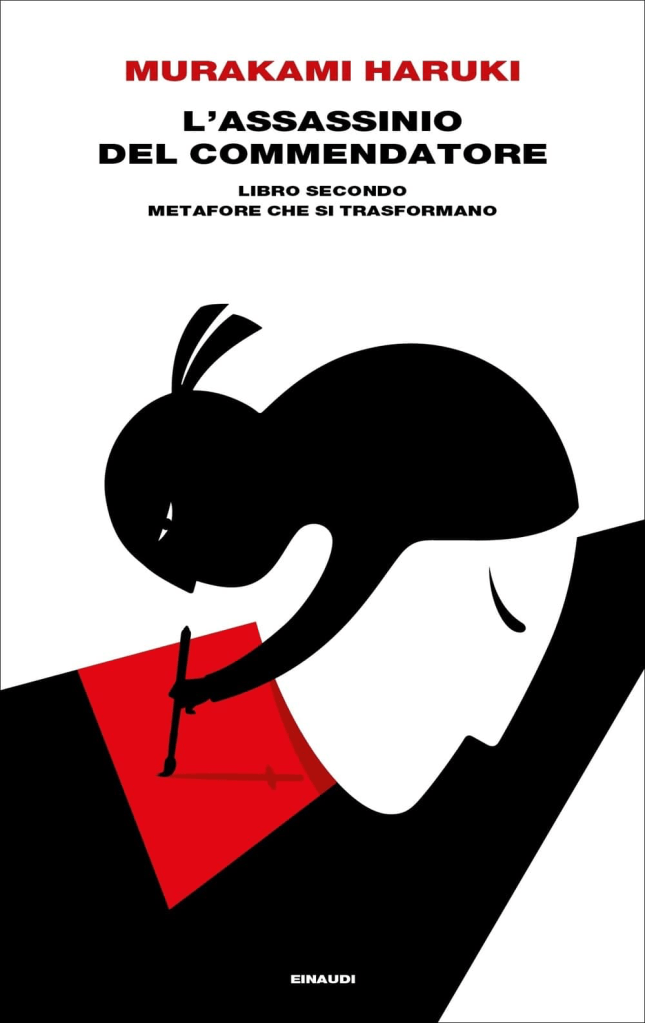

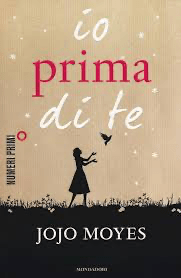
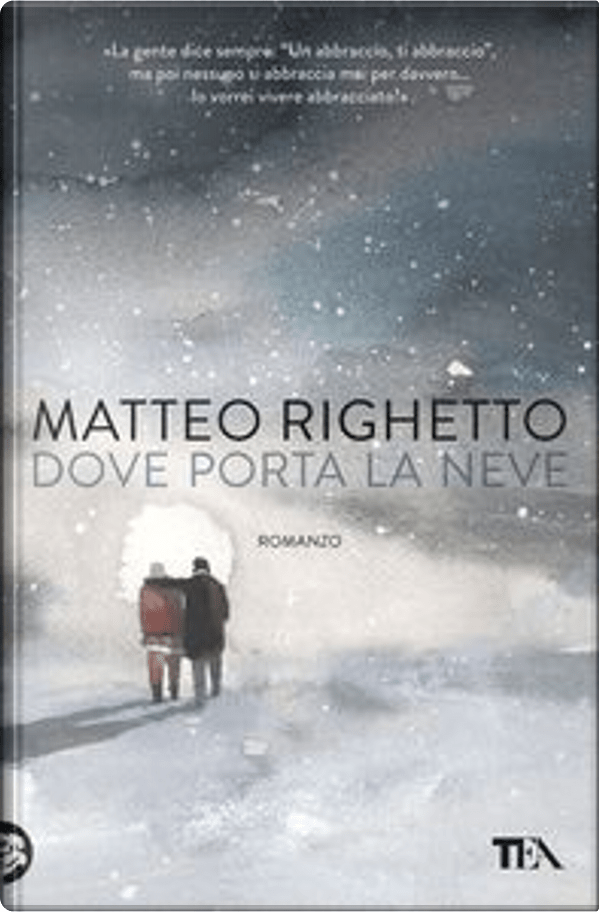
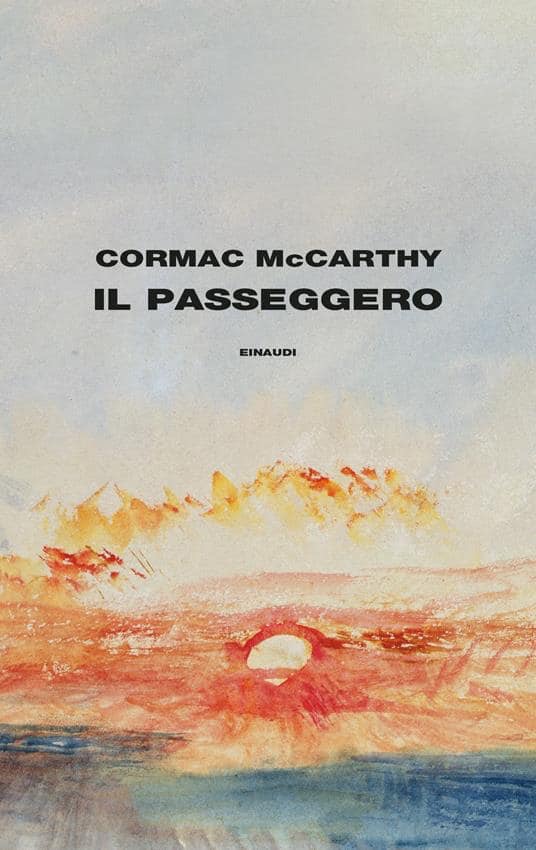
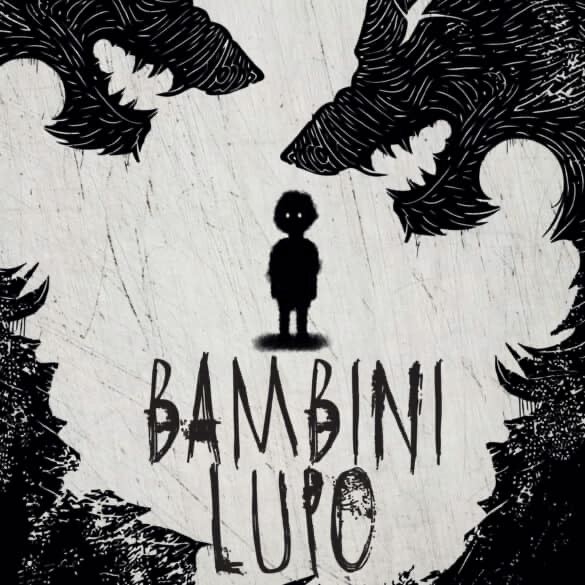
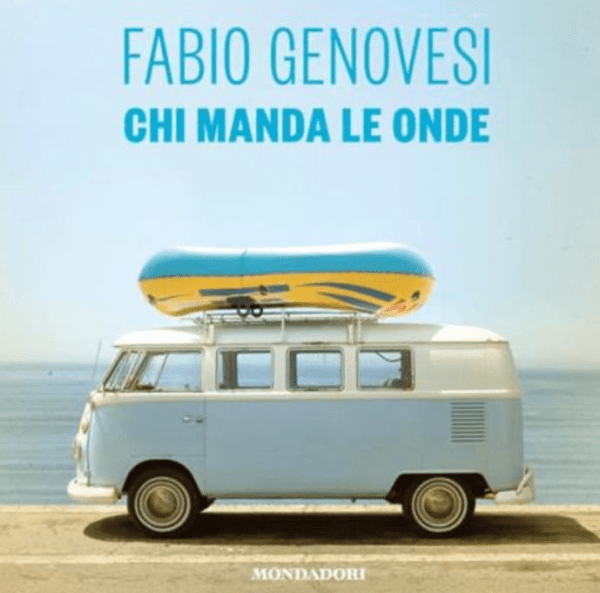


Commenti recenti