Ci sono riflessioni che fanno male. Se questo avviene – spesso si sente dire – è perché si avvicinano al vero. Il problema è questo: sento spesso parlare di patrioti, sovranisti e nazionalisti, di patriottismo, sovranismo e nazionalismo, per indicare persone politicamente schierate o simpatizzanti per la destra. Lasciamo stare il fascismo che non è più categoria politica dell’attualità, ma della storia e i cui emuli attuali appartengono più al folclore che alla politica. Si tratta di parole di cui spesso non si conosce né la storia, né il significato e per questo usate a vanvera. Se la storia delle parole che si usano fosse nota, se si avesse consapevolezza della profondità storica del lessico di cui si ci serve nella pratica giornalistica come in quella politica – quel lessico che è sempre bello investigare e che il mio mestiere mette nella fortunata condizione di poter studiare ogni giorno – ebbene, probabilmente sarebbero state effettuate altre scelte. Insomma, si tratta di parole e, siccome per me la parola è il pane, sia quando sono in cattedra al mattino, sia dietro una tastiera nel resto della giornata, meritano una riflessione, stabilendo come premessa cattiva – tanto per esser chiari, quella che riesce a rendere sempre antipatici i professori – che usare le parole senza conoscerne il significato già di per sé dovrebbe essere qualcosa di inqualificabile. Non solo: farlo con una certa presunzione e con il chiaro intendimento di esibire sui social chissà quale immagine di sé suscita persino un misto di tenerezza e di compassione, oltre che di naturale indignazione, in chi abbia un minimo di preparazione linguistica per capire quanto puerile sia un tale atteggiarsi. E questa seconda è la premessa buona, che però, me ne rendo conto, può fare male tanto quanto la prima.
Come ovviare? Prima di rispondere e di esporre la mia tesi, concedetemi una terza riflessione preliminare: purtroppo, ha ragione chi sostiene che i social abbiano dato la possibilità di scrivere soprattutto a chi sarebbe molto meglio che imparasse la nobile arte del bel tacer che mai scritto fu. Lo dice Eco e, se cito Eco, penso proprio di essere al di sopra di ogni sospetto. Chi ha memoria delle due fasi, del prima e del dopo, constata che non si è verificata quella gradualità di passaggio che spesso i processi della comunicazione conoscono: ci si è trovati in un attimo catapultati direttamente dalla società della scrittura controllata e mediata, che richiedeva sempre il passaggio attraverso una redazione, un giudizio, un vaglio di qualità e un imprimatur finale, a quella in cui ciascuno può sostanzialmente dire tutto quello che vuole, quando vuole, come vuole, senza alcun controllo né sulla forma né sul contenuto (fatta eccezione per quelli che ledono certe sensibilità e non rispettano un certo politically correct, dai contorni comunque assai labili e mai sufficientemente chiari). Ci sono poi quelli come me, molto all’antica – nel bene e nel male, lo ammetto serenamente – che giudicano le persone anche dalla precisione nell’uso della lingua e che non riescono proprio a finire la lettura di un testo che inizia anche solo con un errore di punteggiatura. Figuriamoci di ortografia! I social sono lo scempio della lingua e, ci piaccia o no, contribuiranno al degrado, non allo sviluppo della comunicazione. Lo sfogo finisce qui. Termina qui anche la lunga premessa, poiché, innanzitutto, non intendo trovarmi invischiato nelle trappole della sociologia della comunicazione, e, in seconda istanza, non è mio intendimento apparire noioso. La mia riflessione vuole limitarsi soltanto al piano della linguistica e, in certo senso, a quello della retorica. E se questo per voi è noia, siete sempre liberi di leggere altro.
Ebbene, a che pro questa premessa, ben consapevole di avervi tediato abbastanza? Serve per cercare di capire che cosa s’intende quando ci si riempie la bocca con quelle parole di cui parlavo inizialmente: ‘patriottismo’, ‘nazionalismo’ e ‘sovranismo’. Innanzitutto si tratta di parole e come tali hanno una vita di millenni. Cerchiamo di ripercorrerla, senza scomodare paludati lessicografi. Ci vengono tramandate in modo molto semplice, con un significato che è costruito addosso, come un vestito su misura, dalla tradizione letteraria del popolo che le legge e degli autori che le scrivono; i contesti sociali e culturali possono attivare quei meccanismi di estensione e traslazione semantica che i dizionari puntualmente aiutano tutti noi a comprendere; infine, il lettore può riferire quelle parole a un suo vissuto e interiorizzarle come crede, secondo le sue conoscenze e le sue esperienze. Dunque, cerchiamo di capire, perché la materia è un po’ più complessa di quanto possa sembrare a prima vista.
Partiamo da ‘nazionalismo’. La parola viene da nazione, che a sua volta viene dal latino natio, che significa insieme di persone accomunate dalla stessa nascita, natus. Il suffisso -ismo in questo caso ha finito per assumere quella connotazione dispregiativa e radicale, che il vocabolario registra come ultimo significato. Ma il nazionalismo, come atteggiamento prima culturale e poi politico, affonda le radici niente meno che nella riscossa romantica e anticlassicistica tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. In quel contesto diventa promotore di una sensibilità nuova senza la quale non ci sarebbe stato il meglio della letteratura, dell’arte e della musica di quel secolo, a partire dalla Germania e dalla Francia, per estendersi, con le opportune e inevitabili diverse declinazioni culturali, nel resto dell’Europa. Perciò, andiamoci piano a usare il termine convinti di farlo per offendere. Qualcuno, che ha letto qualche libro più di voi (ci sarà sempre la persona che ha letto un libro più di noi: scendiamo dal pero e facciamocene una ragione), potrebbe anche ringraziarvi e lasciarvi a bocca aperta, quanto meno con una curiosità di capire perché non si è sentito offeso. Forse perché conosce qualcosa di più di quello che pretendi di sapere tu? Partiamo sempre da questo: niente è perfetto nella lingua, tutto è perfettibile; niente è assoluto, tutto è adattabile e passibile di mille interpretazioni. Ma soprattutto, facciamo quel piccolo sforzo di capire le parole che usiamo.
Seconda parola: ‘patriottismo’. Viene da patria, che in greco indica i beni dei padri che passano ai figli; da qui l’estensione del significato, dai beni di casa a quelli della casa comune di tutti, lo Stato; estensione che in lingua latina è già compiuta e che da quel contesto linguistico passerà a quella italiana attraverso il filtro dei volgari e la complessa interazione con i vari idiomi allogeni da nord, da est e poi anche da sud. Il patriota non è altro che colui che ha ben chiaro il significato del suo agire politico: tramandare ai figli valori che ritiene validi, di cui ha sperimentato l’efficacia per il progresso. Il patriota è colui che guarda con un occhio in avanti, indietro con l’altro, che costruisce il futuro sempre memore di quanto ha ereditato. Usare il termine in altre accezioni è una violenza alla tradizione linguistica. Pensare che essere patriota sia il marchio qualificante un’azione politica schierata ed etichettata non è soltanto un errore madornale, ma può rivelarsi anche un micidiale boomerang: basterebbe, tra i mille esempi che si possono menzionare, ricordare che tanti combattenti schierati a sinistra negli anni della guerra civile tra il 1943 e il 1945 si sono chiamati patrioti. Il patriottismo è un grande valore della tradizione. Non ha colore. Non sopporta marchi. Se lo si usa come categoria politica, va rispettato in chiunque lo comprende a prescindere dal suo schieramento.
E adesso veniamo alla parola che per me è forse la più brutta che il lessico politico abbia prodotto in tempi recenti: ‘sovranismo’. La parola è talmente giovane che chiunque può dire tutto e il contrario di tutto in mancanza di quegli appigli nella tradizione che le altre due, che abbiamo appena esaminato, consentono di avere. Sovranismo viene da sovrano, che è un derivato dell’avverbio e preposizione super, sopra. Sovrano è chi sta sopra a tutti e non ha bisogno di rendere conto a nessuno del proprio operato. Il sovrano è il monarca. Punto e basta. Usare questo termine al di fuori di questo contesto per indicare comportamenti sociali, culturali, politici ed economici significa non avere la più pallida idea del significato di questa parola. Il sovranismo è quanto di peggio possa esserci per un politico, un politologo o un giornalista che si è formato ed educato nella scuola dello stato moderno di tradizione europea occidentale; il sovranismo richiama l’assolutismo monarchico in cui il popolo è soltanto suddito e non partecipe, esattamente tutto quello contro cui la cultura del nostro continente ha per secoli combattuto, prima soltanto nelle corti rinascimentali e soltanto in ristrette cerchie accademiche, poi anche con le grandi rivoluzioni e nei moti libertari dalla fine del XVII all’inizio del XX secolo, senza distinzione tra quelli ‘carbonari’ di origine liberale e più elitaria e quelli ‘rivoluzionari’ di matrice popolare. Eppure qualcuno riesce a vantarsi di essere sovranista, senza sapere cosa sta dicendo e quale vocabolo sta usando. Che la parola possa essere brutta ammetto e concedo che possa dipendere soltanto dalla mia incancrenita e incorreggibile sensibilità purista; ma che la sua storia, molto giovane, sia questa e che la sua base etimologica sia questa credo che difficilmente potrà essere negato. Insomma, lasciatemi dire che prevedo che ciò che nasce da brutte radici difficilmente potrà dare buoni frutti. Per favore, cestiniamo quest’obbrobrio e cerchiamo qualcosa di più consono alla bellezza che la nostra nazione nei secoli ha saputo esprimere.
Ma procediamo. Siccome non mi piace distruggere un ragionamento senza provare a costruirne un altro, la domanda che mi viene spontanea è questa. Pronti? Siete seduti? Ecco: attenti che ora sparo. Come mai nessuno ha più il coraggio di dirsi socialista? Abbiamo assistito al fallimento del comunismo come esperienza politica, abbiamo assistito al fallimento del neoliberismo, della convivenza tra liberalesimo e cattolicesimo e di tanti altri -ismi. Ma il socialismo? Chi ha avuto mai il coraggio di sperimentarlo veramente? Trovatemelo e mi richiudo ad aeternum sul monte Athos. Qualcuno ha mai veramente provato a capire esattamente che cosa sia, al di là delle tante utopie più o meno campate per aria di cui i libri sono purtroppo pieni? La sua etimologia è a dir poco meravigliosa: ci riporta a socius, vocabolo che in latino indica l’amico che ti segue (molto seducente l’ipotesi che propone il collegamento con il verbo sequor dalla radice seqw-), l’amico che è legato a te dalla condivisione solidale di un sistema di valori e regole, dall’essere permeato del crisma di una humanitas dai contenuti robusti, dal conoscere, vagliare, sperimentare e tramandare le consuetudini di una tradizione e i principi di uno stato di diritto. Vi dirò, a me questo piace davvero tanto. Eppure, quante volte, soprattutto negli anni novanta, l’etichetta di socialista veniva affibbiata come sinonimo di corruzione? In Romagna ch’t’an faza e’ sucialesta! (che tu non faccia il socialista!) è diventato ormai un detto proverbiale per dire ‘non rubare!’ E dunque? Soltanto per il fatto che qualche sedicente socialista ha rubato, dobbiamo necessariamente buttare il bambino con l’acqua sporca? Ma, per favore … Il socialismo ha preso storicamente strade diverse, si sa. Ha imboccato quella del comunismo e quella del fascismo. Si è evoluto in forme totalitarie. Ha visto spesso sovvertire le sue basi in nome di una diversa collocazione del baricentro semantico, in un sistema-partito ad est, in una persona carismatica ad ovest. Ha sperimentato anche commistioni con tradizioni religiose indigene, come accadde a Cuba. Ma restiamo alle radici della pianta e non consideriamo i frutti, che possono anche marcire. Il socialismo, allo stato embrionale di idea, quella memore del significato della parola – per me sempre molto importante – resta alla base di ogni più naturale e schietta aspirazione del popolo. Chi si sente socius sa apprezzare la bellezza della solidarietà, mette l’altro sempre davanti a se stesso e, quando si tratta di progettare, erogare e attuare un servizio, il politico che si sente socius pensa sempre prima al più debole tra gli utenti di quel servizio, anziani e disabili, bambini e persone violentate, per esempio. Il politico che si sente socius non ammette alcuna servitù e non può non apprezzare una costituzione che parte dal lavoro, come la nostra. La persona di cultura che si sente socius dialoga con tutti nel mondo del lavoro, nelle piazze, nei luoghi d’incontro, non vomita odio represso da una tastiera, non si chiude nel mondo finto dei social, comodamente filtrato da uno schermo. Il socius vive una vita vera, in cui si può essere materialisti come spiritualisti, ma si è sempre accomunati da una prassi metodologica che può avere tante forme, ma punta allo stesso traguardo: può essere un principio di metodo o un dettato d’indirizzo che si esprime in una prassi di comunità, di solidarietà, di fratellanza, di squadra e di unione. Il traguardo è quello di sempre di ogni politica vera: sarà il bene dello Stato per alcuni, della Patria per altri, della Nazione per altri ancora, ma non sarà mai quello del partito, mai quello del suo capo.
Mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse che vorrebbe ripartire con me da qui, come mio socius. Occorre coraggio? Eccomi, ce l’ho. Potrò avervi annoiato, potrò aver lasciato dell’amaro in bocca a qualcuno, potrò aver detto qualcosa che fa pensare più di quanto si sarebbe inizialmente pensato, ma quello che a me preme è soltanto essere riuscito a conseguire un obiettivo, arrivato alla fine del ragionamento. Quale? Non aspettatevi niente di eclatante. L’obiettivo è questo: dopo aver dovuto esporre una lunga premessa, dopo la stesura di una parte centrale di tipo confutatorio, dopo una proposta concreta e, se così si può dire, ‘operativa’ nel finale, lasciatemi almeno l’illusione di nutrire una certa convinzione, quella, per l’appunto semplicissima, di non aver usato parole a vanvera. Per davvero, mi basta questo. Enea non pianse un amicus, quando perse nel silenzio di una notte di bonaccia il nocchiero Palinuro; non pianse un comes, un compagno. Enea pianse un socius. E come reagì? Si stracciò le vesti? No. Maledisse gli dei e il fato? No. Si mise lui al suo posto e portò la nave a destinazione. Questo a me piace.


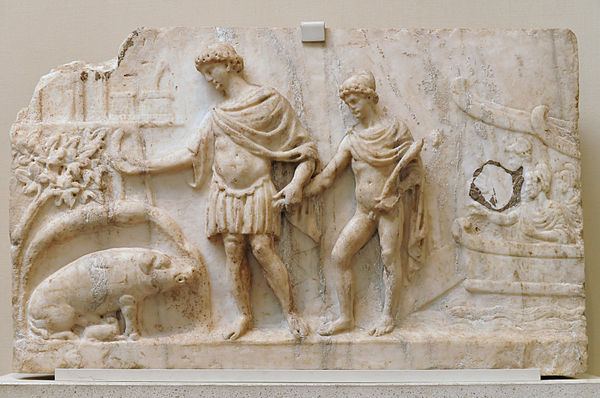




Commenti recenti