Uscendo dal ristorante e passeggiando, una domenica tra amici in collina trascorre tra ricordi e progetti, in quel sottile filo di demarcazione che ti costringe a barcamenarti tra passato e futuro. Lasciarsi cadere da una parte o dall’altra sarebbe bello ma allo stesso tempo rischioso, intrigante ma anche pieno di interrogativi. La fine del pranzo è come la liberazione da quella sensazione di essere vissuto sospeso. Capita spesso. “Guarda!”, mi dice lei, indicando in alto. Ma gli occhi vanno in basso.
L’uscita all’esterno apre ad altri scenari. Lei è con me. Mi prende a braccetto. Condivide mondi di cui non lascio a nessun altro la chiave. Mi guarda e sorride. La guardo e un sospiro non mi consente di sorridere. Lei alza lo sguardo in alto a occhi chiusi. Abbasso il mio sulla scarpa, sulla stampella, su quel sentore di differenza di cui lei non ha mai avvertito la carica negativa. Osservandola con morbosa curiosità i più non ti considerano degno di essere messo a parte dei loro progetti. Fu segno di chissà quali diaboliche macchinazioni, ordite per metterti in un cantone e giustificare il tuo isolamento. Fu causa di solitudine, di dolore, anche di malinconia. Fu motivo di convinzione di non poter godere delle medesime gioie dei più. Fu dolore. Ora è nostalgia, un po’ dolce, un po’ amara. In questo mondo segreto e complice vagano le nostre due anime. “Guarda!”, ripete lei indicando in alto a me che sono sempre attratto in basso, stringendo la morsa sul braccio.
Qualcosa accade lassù. Quell’aria tersa ammalia con una forza speciale: la memoria allora lavora e ti fa sentire libero, come quando il babbo ti guidava in quel paesaggio di irti pendii boscosi e possenti frange rocciose, che adoravo più di qualsiasi altro territorio: meritato il riposo della salita, sulla cengia o sul pianoro, sul valico o sulla forcella, potevo ammirarlo sicuro e fiducioso nei miei mezzi, tutt’altro che scontati, diversi dai canoni condivisi. Procedere al traguardo con mezzi non convenzionali non è un problema, se l’anima trova occasione di librarsi lassù. Occorre un aiuto: noi due lo abbiamo avuto. Ora innalzo anch’io lo sguardo.
Si comprende se si vive quello spirito di differenza come occasione per osservare tutto da un punto di vista originale. La montagna, la sua aria, i suoi venti, il suo spirito, che sa parlare una lingua amica, in me producono questo effetto. Tutto è diverso e la differenza è un valore, non un difetto. L’aria della bassa, invece, mi invita a stare a testa china. Il piano mi fa sentire servo della memoria. So che è parte indissolubile di me, ma non amo darla in pasto a sguardi che non la meritano. Sono gli effetti di quelle radici che si piantano. Poi tu cresci, ma loro ti tengono abbarbicato al tuo destino. Se le recidi, perdi tutto. Anche se tu ti innalzi, come è giusto che nella vita accada, alla fine ti ricorderai sempre di loro, perché prima o poi ti costringeranno a farlo. Essere quassù significa tornare laggiù, in quella nostalgia che non è mai sterile rammarico, né inutile pentimento. Ha il sapore dell’accettazione di un destino che non hai nessun diritto di modificare. Saresti empio e irriconoscente, se lo facessi. È segno di umiltà riconoscerlo come marchio di fabbrica con ingenua fierezza. Così vagava la mia mente, finché lo sguardo non la condusse altrove. “Guarda”, ripete lei.
Adesso la vedo. Lassù un’aquila reale volteggia solitaria. Da un po’ di tempo si avvista con una certa frequenza, ma il momento in cui si riesce a vederla è sempre uno spettacolo per l’anima. Dice un amico che nidificano anche sulle cime degli alberi della grande abetina che si apre pochi chilometri più su verso il crinale; aggiunge che erano solo poche coppie quelle inserite inizialmente, ma che ora sono una quarantina. E comincia a leggere del programma di inserimento dei rapaci nel parco, dall’aquila reale al falco pecchiaiolo. Lo lascio sciorinare le sue statistiche. Gli altri scattano foto. Non so cosa ascoltino le mie orecchie; so cosa ascolta adesso il mio cuore. A me interessa altro. A lei anche.
La ammiro. La maestà del volo dell’aquila è qui, sopra di me. La perfezione ossessiva dei suoi giri, ripetuti più volte, alla ricerca di chissà quale conquista, mi attrae a sé come un magnete. Ma sono docile. Non sento il dolore della differenza che mi segna. Avverto unicamente la forza della libertà che troneggia lassù. Quel volo che ostenta forza e sicurezza non ricorda forse che la natura ci ha progettati per essere ammirati quando siamo predatori e leoni, maestosi guerrieri che lottano per la vita esponendosi e non nascondendo di se stessi nulla, soprattutto quella differenza che è il tuo valore aggiunto, quella che gli altri potrebbero ritenere un errore di progetto, un anello che non tiene, uno scarto di produzione? Non ricorda forse che quello che tu hai ritenuto un errore di fabbrica è proprio la parte più significativa del tuo esistere, del tuo essere come quell’aquila? E tutto questo non si realizza forse quotidianamente in un mondo in cui per conigli e iene non c’è altro spazio che la vergogna e il disonore? Non importa. Lo spettacolo va in scena: la maestà dei volteggi dell’aquila con la grazia del suo impercettibile colpo d’ala; la perfezione del disegno che traccia su di un azzurro immune da macchia, qui al margine della cerreta, in una selvaggia terra che qua e là sbuffa gas e non dimentica la sua natura vulcanica; il conforto dell’amicizia solidale che fa da armonico controcanto a quella potenza solitaria che volteggia lassù; la sicura compagnia di lei che mi ha seguito ancora una volta per mano fino a un traguardo speciale, la conquista di un altro tassello di quel senso vero di una vita che è tale solo se è audace lotta quotidiana, temeraria, là dove tutti ti vedono, ma nessuno ti cattura, là dove la paura non esiste, la sicurezza è energia, la fiducia in se stessi è tutto quanto possiedi per il futuro, la nostalgia non è mai rimpianto. La conoscenza del vero valore della vita, da sempre, per me ha avuto come occasione per intraprendere il suo viaggio nella bellezza la rappresentazione che l’anima sa offrire di quanto i sensi catturano per lei: oggi un’aquila reale. E con lei la montagna, i ricordi, il babbo, l’incomparabile bellezza della nostalgia, e lei qui accanto a me, la coda di cavallo al vento, gli occhi neri che sfondano ogni barriera, la sua mano che mi stringe sicura. Senza la nostalgia non ci sarebbe quella ricarica che il dolore di ieri ti dà oggi. Il braccio di lei si stringe ancora di più al mio. L’amico termina la lettura della sua guida, ricordando che le aquile reali di solito cacciano in due: una vola bassa con il fine di incutere paura nella preda, mentre l’altra cerca di catturarla dall’alto. È vero. Lo diceva sempre anche il babbo, lassù in cima ad altre vette. “Per me ce n’è un’altra da qualche parte”, dice l’amico, riponendo la guida nello zaino, Mi allunga un binocolo. Gli altri cercano, ma non trovano e si allontanano verso le auto. Rimaniamo noi due. Il vento porta i suoi capelli ad accarezzare le mie guance. Il tempo amico, l’esperienza che ammaestra e fa di noi aquile e querce, la bellezza della nostalgia condivisa negli anni, tutto questo guida lentamente il suo viso silenzioso sorridente sulla mia spalla.
“Mi sento lassù. Sai, sono un po’ come quell’aquila. Mi sento libero, forte e fiducioso predatore. Sono finalmente quello che sempre sarei voluto essere,” mi sfugge sottovoce, alzando gli occhi, volando basso, convinto che solo lei senta.
“Sì. Credo proprio che sia l’incontro che mi ha cambiato la vita,” dice lei, volando dall’alto, abbassando lo sguardo e incontrando il mio.
“La nostra vita necessita di queste ricariche e ha bisogno della forza della nostalgia,” le sussurro, accarezzandole una guancia.
“Per questo siamo qua. Per fare di quella nostalgia la nostra comune passione,” dice lei, mentre, portato dalla brezza, il suo viso si accosta al mio. Più giù, sopra una macchia di farnie, eccola. È l’altra. Sì, erano due. L’amico aveva ragione. Il babbo è contento. Seguiamo gli altri alle auto raggiungendoli. Un ultimo sguardò lassù. La nostalgia è nostra. Non ci lascerà. Il premio è meritato.

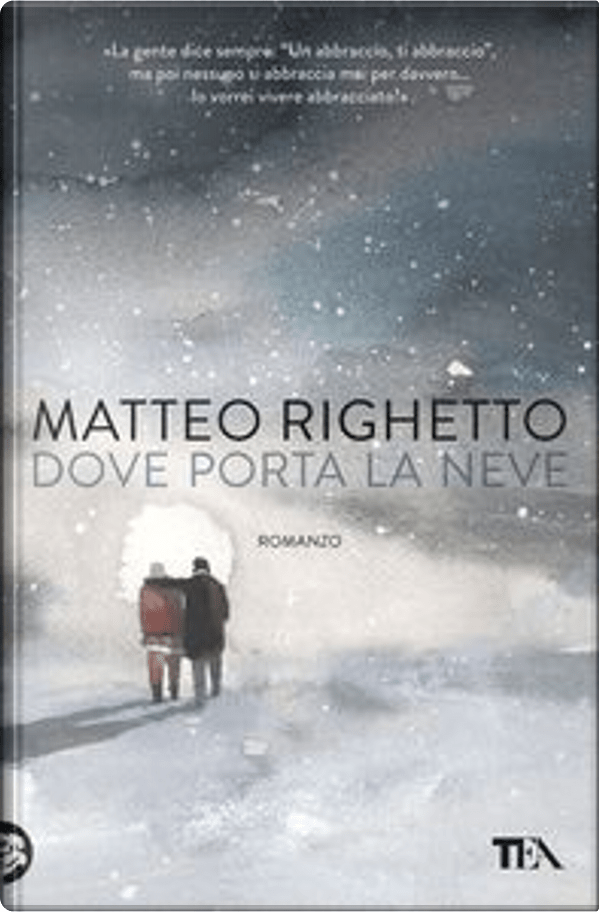









Commenti recenti